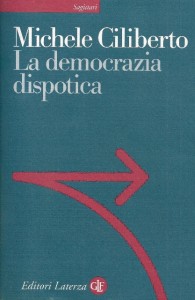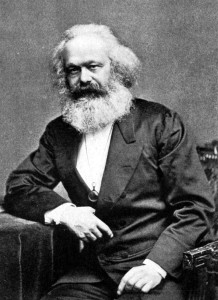Accennerò appena agli assalti ai rifugiati di Quinto di Treviso e di Casale San Nicola. Essi sono degli episodi (non i primi e probabilmente non gli ultimi) che meritano di essere considerati non solo per le conseguenze materiali prodotte (in primis su quei poveri uomini «trattati come cani, picchiati e insultati» ), ma soprattutto per quel che rappresentano nella attuale narrazione della politica italiana (ed europea). Attraverso il Jobs Act e la “Buona Scuola” il governo Renzi ha completato l’obiettivo perseguito da Mario Monti con la riforma Fornero e la legge sul pareggio di bilancio in Costituzione, ovvero quello di “distruggere la domanda interna”, come lo stesso Monti aveva dichiarato nella sua intervista alla CNN del 2013 . Durante la crisi, le istituzioni e i poteri dello Stato italiano hanno definitivamente dismesso quelle poche lacere vesti di enti “super partes” del conflitto sociale e si sono completamente trasformati in strumenti “privati”, immediati e arbitrari della classe sociale dominante che ha gestito la crisi e dei novelli “despoti” (ieri Berlusconi, oggi Renzi, domani Salvini?); sulle ceneri dello Stato liberale novecentesco si erge la contemporanea democrazia totalitaria, basata su governi “carismatici” e modelli politici leaderistici in cui, va riconosciuto, buona parte della società si riconosce. Una classe politica corrotta e dequalificata, aveva già denunciato Michele Ciliberto qualche anno fa , gestisce un nuovo autoritarismo di massa imperniato sull’esercizio del consenso, attraverso gli immaginari diffusi e conculcati dai media mainstream. Come hanno invece recentemente ricordato Judith Revel e Sandro Mezzadra durante il Festival Internazionale dei Beni Comuni a Chieri, la linea di demarcazione fra “pubblico” e “privato” è diventata impercettibile, a scapito della solidarietà e del concetto di “comune”. In questo contesto che ho sommariamente ricostruito, i partiti del populismo xenofobo e nazionalista (Lega Nord, Fratelli d’Italia, in parte Movimento 5 Stelle, coi loro addentellati come Casa Pound e Forza Nuova) si sono abituati a muoversi perfettamente su un terreno in cui le politiche autoritarie della “terza repubblica” e la crescita dell’individualismo e dell’egoismo sociale stanno creando (sicuramente con importanti, ma rare eccezioni) seri problemi di isolamento sociale alle idee e alle forze che si basano sull’azione collettiva, sul conflitto sociale, sulla solidarietà di classe. Nelle vuote navate di una cattedrale costituzionale ormai svuotata (basti pensare alle attualissime riforme istituzionali), si ingrossa e si moltiplica quindi la voce dei razzisti e dei “fascisti del terzo millennio”. L’aumento costante delle pressioni sociali accelerato anche dalle contraddizioni aperte dal processo di unificazione europea (il cui vero volto di operazione di strozzinaggio internazionale i fatti di Grecia hanno oggi mostrato), danno oggi rinnovato spazio a queste forze, che solo pochi anni fa erano ridotte a relazionarsi con i vari governi, come coloro che, magistralmente rappresentati da Ken Kalfus nel suo romanzo “Il compagno Astapov”, aspettavano la morte di Tolstoj per riuscire ad accaparrarsi qualche briciola del suo testamento.
Gli episodi di Treviso e di Roma Nord, come altri che l’avevano preceduto (assalto al centro rifugiati di Tor Sapienza a Roma nel novembre 2014; caccia all’uomo a Corcolle, sempre Roma, nel settembre 2014), sono sì il prodotto dello sfaldamento sociale e identitario (in termini di appartenenza di classe) del mondo del lavoro autoctono, nel quale però le bande neofasciste e xenofobe spadroneggiano, grazie alle “larghe intese” delle forze filo-austerità e all’inanità delle residue e sempre più assottigliate forze della cosiddetta “sinistra radicale”, e col sostegno ponziopilatesco dei dirigenti del M5S, come testimonia l’intervista a Di Battista del 18 luglio .
Non nutro alcuna fiducia, tanto per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, in eventuali provvedimenti del Governo, che anzi ha dimostrato, in epoca recente, dall’aggressione agli attivisti del Centro Sociale Dordoni di Cremona alle medaglie d’oro assegnate “per errore” agli ufficiali repubblichini, la sua continuità coi governi precedenti in tema di rimozione della memoria della Resistenza e di sostanziale impunità del neofascismo.
Il mero antifascismo e antirazzismo, sebbene condizione necessaria, è però, per quanto scritto all’inizio, non sufficiente. Esso non ci mette al riparo dalle drammatiche conseguenze della macelleria sociale operata nei confronti di un mondo del lavoro ormai profondamente diverso e molto più sfaccettato e (attualmente) debole di quello novecentesco. Distruzione della domanda interna fa rima con austerità, alla quale dobbiamo saper rispondere con nuove rivendicazioni e con un nuovo modello di welfare riappropriandoci, come ha detto Toni Negri sempre nel festival di Chieri, del “comune” (inteso come sostantivo e non come aggettivo) che ci appartiene. Per fare ciò, però, dobbiamo avere chiaro che lottare contro il “nostro” Governo non sarà sufficiente e che oggi ci troviamo di fronte un soggetto – l’Unione Europea e le sue strutture, dall’Eurogruppo alla Commissione, dal Consiglio d’Europa alla BCE – che costituisce il sistema europeo dell’austerità. D’altronde, per tornare al tema iniziale, è lo stesso sistema che blinda i suoi confini e i suoi mari (dal Mediterraneo alle Alpi, dalla Manica ai Carpazi), col terrificante e vergognoso corollario di morti migranti, di pogrom razzisti, di populismo xenofobo che, come è sotto gli occhi di tutti, non riguarda solo l’Italia.
Lotta contro xenofobia, razzismo e neofascismo e lotta contro l’austerità sono quindi aspetti inscindibili, e la dimensione nazionale, sebbene immediata e inevitabile, rischia di essere depotenziante se non si inscrive nel contesto più ampio di un movimento di opposizione politica e sociale a livello europeo, se non anche mediterraneo. Di questo compito urgente non possiamo illuderci si facciano carico le continue riorganizzazioni dei settori della sinistra istituzionale eredi della tradizione del PCI (ex PD, SEL, PRC, ecc.), che, sebbene impegnati in un eterno rimescolamento delle (poche) carte che ormai hanno a disposizione non hanno alcuna intenzione di uscire dalla logica politica che vuole ricercare a tutti i costi una compatibilità fra i nuovi assetti imposti dall’austerità e dalla democrazia totalitaria e le prospettive di liberazione sociale per quel “nuovo proletariato” precario (autoctono, meticcio o immigrato che sia) che proprio dell’austerità è la prima vittima.
In ballo c’è molto e le prospettive sono francamente fosche al momento: la guerra civile in Ucraina, la destabilizzazione in tinta islamista dei Paesi del lato sud del Mediterraneo (Libia, Tunisia, Egitto), ed infine il terribile diktat imposto dall’Eurogruppo a guida germanica alla Grecia di un (alla fine) pavido Tsipras sono inquietanti avvisaglie di un processo politico in cui, nel nome della stabilità e della crescita finanziaria, si destabilizzano non solo società e popolazioni ritenute subalterne ed “inferiori”, ma si fomenta un nuovo nazionalismo che oggi assume i contorni delle contraddizioni franco-italiane a Ventimiglia o britannico-europee sull’immigrazione, oppure della follia ungherese del muro contro l’immigrazione serba, ma che, in un ipotetico quanto probabile peggioramento delle generali condizioni economiche e sociali nel continente europeo – dovute sempre a quella “distruzione della domanda interna” che sembra diventata la nuova religione del mercato – potrebbero non tardare a far deflagrare conflitti molto ben peggiori di quelle attuali.
Ecco, oggi in Italia ci si trova ad una svolta molto grave della nostra vita sociale, politica e culturale, senza avere gli strumenti necessari per capire cosa fare e come farlo. Gli avvenimenti ucraini, greci, nordafricani, ecc. sono rimasti conoscenza solo di pochi “addetti ai lavori” o militanti generosi, come testimonia la insufficiente partecipazione di massa alle manifestazioni o attività di sensibilizzazione che in questi mesi sono state organizzate.
Come ha giustamente scritto la redazione di Effimera qualche giorno fa, l’Europa è in guerra . Non solo una guerra economica “civile” dichiarata dalle élites finanziarie agli abitanti dell’UE, ma anche una guerra “di civiltà” dichiarata di fatto ai Paesi nordafricani e mediorientali, e una guerra di espansione dichiarata a Est contro la Russia attraverso la guerra civile in Ucraina. Una guerra che però si sta già ritorcendo contro la stessa fortezza Europa (come dimostrano i sanguinosi fatti di Parigi) e che potrebbe in breve, medio periodo deflagrare nel cuore stesso dell’UE, qualora la questione greca (come io credo) non dovesse risolversi per il “meglio”.
Conclusione? È sicuramente necessaria quella razionalità e quella profondità di comprensione degli avvenimenti che eviti di farci scivolare dentro una nazionalistica “opposizione anti-tedesca” (pur essendo la Germania la prima protagonista della macelleria sociale europea). Al tempo stesso è però necessario rimettere in moto intelligenza, passione e generosità per riconnettere i fili di un’opposizione politica e sociale all’austerity (e alle recrudescenze razziste e fasciste che ne sono uno dei prodotti) non solo sul piano nazionale, ma quanto meno europeo. Avendo, infine, presente che di fronte ci troviamo (e ci troveremo) un potere oligarchico continentale (e le sue propaggini nazionali) oramai divenuto una perversa commistione di potere pubblico e privato che ha di fatto svuotato, come aveva già denunciato qualche anno fa Colin Crouch, le già traballanti democrazie tradizionali attraverso una prassi politica autoritaria.