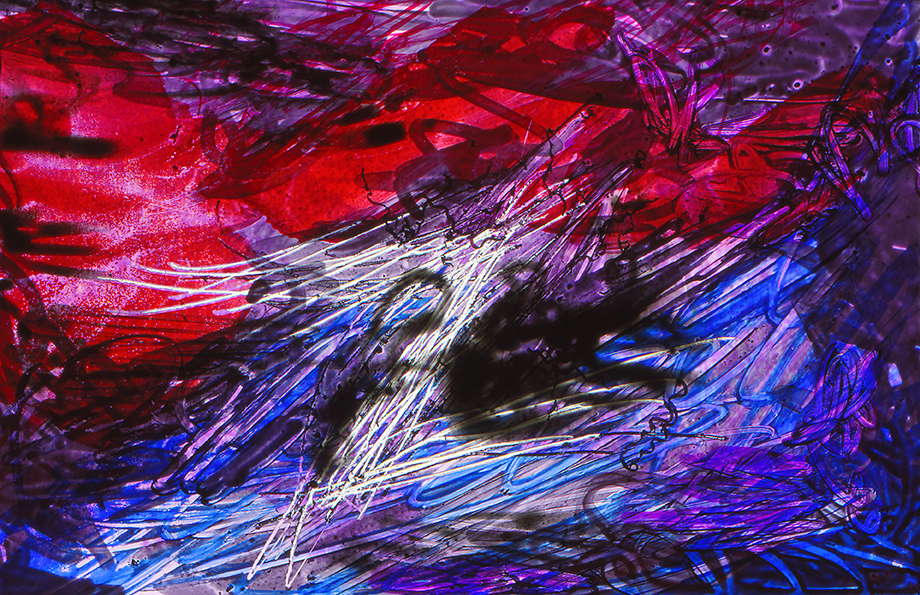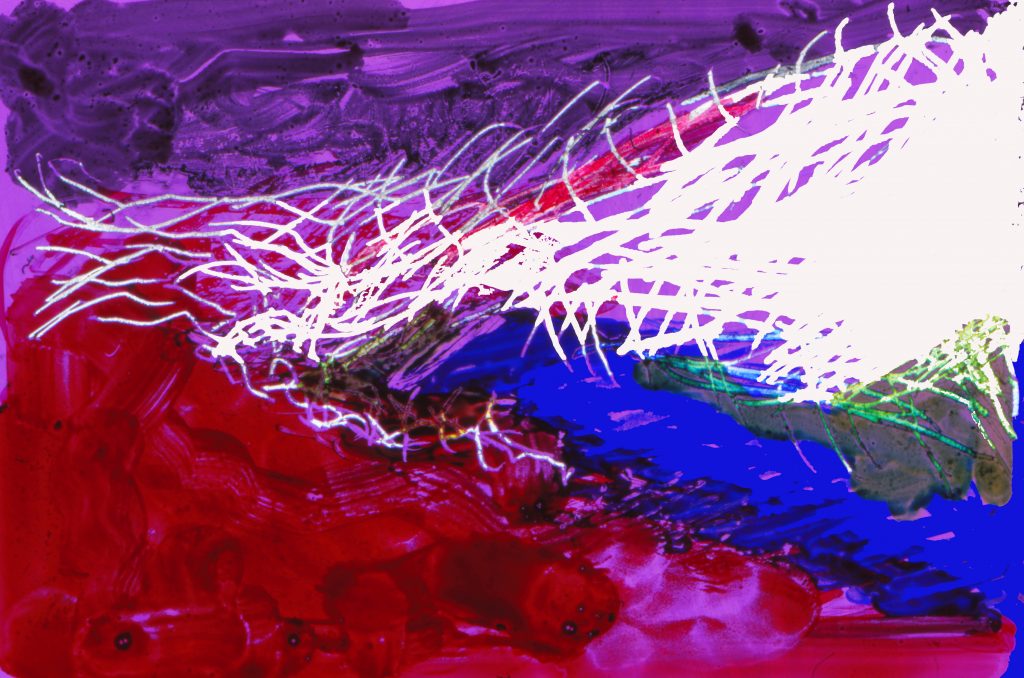Tra le nuove forme di editoria si è affermato con successo il podcast, capace di superare l’istante della trasmissione per poter essere con calma scaricato e fruito quando vogliamo. In questo caso abbiamo – così lo presenta l’editore – un “porncast”, un libro sulla storia della pornografia, narrato in voce a puntate da Melissa Panarello, peraltro non nuova a iniziative trasgressive, sempre che oggi resti qualcosa da trasgredire. E infatti Melissa tira le fila di un fenomeno ormai consolidato: il porno, che esiste da sempre ma assume forme diverse nelle varie epoche, condizionato dalla religione, dalla morale ma anche dai mezzi di produzione e riproduzione dell’immagine. Melissa non perde tempo, come noi all’epoca, a discettare su cosa è pornografico e cosa è solo erotico; in questo la pensa come i giapponesi, i quali non distinguono tra le due categorie. Per lei – riassumo da una delle due prime puntate – l’erotismo è il tentativo di unire l’anima con il corpo, di trovare un equilibrio con il sesso, tipico del segno della Bilancia (il mio, ndr.). Il porno invece va subito al sodo, esprime istinto e fisicità. “Se ami le lenzuola di seta e le manette di velluto questo non è posto per te”, ironizza la nostra amica. Sfugge a Melissa che se il sesso è biologico, erotismo e pornografia sono comunque entrambe elaborazioni culturali, tutte umane, solo che il porno dell’erotismo è il grado zero. E’ la cultura del sesso, declinata ora verso la sublimazione (erotismo), ora verso la pura carnalità (pornazzo). Ed anche una scommessa: significa riempire di elaborate ricette un libro di cucina avendo due soli ingredienti, arricchiti di salse nell’erotismo, ma serviti quasi crudi nel porno. Perché Melissa chiama le cose col loro nome, inutile che tutti giochiamo a fare gli intellettuali quando poi siamo drammaticamente legati alla fisicità del nostro corpo e ai nostri istinti primordiali.
Tutto bene? No, si gioca come al solito sul corpo della donna, che deve mostrarsi attraente ma pudica, disponibile ma casta, davanti a un uomo sempre potente e dominante; ma questo è un vecchio discorso. Quello che è interessante è vedere il passaggio “democratico” della pornografia (termine in teoria greco, ma adottato nel ‘700 dalla letteratura francese) da forme sacre, colte e aristocratiche (come nel Rinascimento o nel Settecento) che poi permeano tutta la cultura e scendono fino agli strati più umili della società, fino a diventare, come oggi, un amorale fenomeno di massa, continuamente capace di adeguarsi al momento e a sfruttare la tecnologia più avanzata, come dimostra oggi l’esplosione del porno in rete, e prima di questo il cinema, il VHS. E’ una storia avventurosa ed è anche divertente ascoltarla dalla voce di Melissa, garbatamente siciliana, la quale è ironica e curiosa di scoprire cosa si sono inventati uomini e donne nel corso del tempo per rendere piacevole la vita in comune; si parte addirittura dalle caverne, dove nell’inevitabile promiscuità qualcuno guarda la coppia che fa l’amore e così inventa il porno (citare Freud e la scena primaria forse è troppo). Si continua con il mondo classico, poi per sciagura arriva il Cristianesimo, e così via. Le fonti documentarie a cui Melissa attinge sono di ogni tipo, qualche volta anche scontate; non mancano banali luoghi comuni, ma in fondo è una simpatica trasmissione radio a puntate. Ancora non siamo arrivati alla Golden Age of Porn americana (gli anni ’70 del secolo scorso), chissà poi se si parlerà di Lasse Braun detto l’Alieno, quello che sdoganò il porno come forma di liberazione ma non capì che sull’affare (esattamente) ci si sarebbero buttati a capofitto avventurieri e delinquenti: “Gola profonda” fu finanziato dalla mafia italo-americana. La vitale gioia del pornazzo nasconde anche angosce di castrazione o almeno disagio e frustrazione in chi guarda (Hitchcock insegna, penso a Psyco o a La finestra sul cortile), mentre il backstage produttivo è intriso di sfruttamento, droga e quant’altro. Resta poi un problema irrisolto: le donne si ritrovano ancora una volta – cito – “incastrate fra due modelli altrettanto inaccettabili di femminilità. Il primo è il modello tradizionale che, persino oggi, è difficile contestare, il quale condanna al disprezzo e all’ostracismo le donne promiscue; inoltre le donne sanno per esperienza che lo stereotipo tradizionale della femminilità è profondamente legato alla sessualità e le costringe a trasformarsi in spettacolo continuo di seduzione ma devono al tempo stesso rimanere modeste e non lasciar mai capire che si stanno esibendo. Il secondo è l’altro modello, ancora vago e inquietante, proposto dalla pornografia, imperniato sulle acrobazie sessuali e sulla soddisfazione completa di tutti i capricci, un terreno che sembra più familiare agli uomini, che affermano di esservi più a loro agio.” (da Bernard Arcand, Il giaguaro e il formichiere). Eppure ci sono ancora donne che vedono nel porno una sorta di sdoganamento della sessualità, basta scorrere il serioso sito Academia.edu.
Quello che è assodato è che il porno si aggiorna e si trasforma di continuo, oggi si adatta alla rete e al fai-da-te, domani chi lo sa, ma richiede comunque grandi investimenti e ancora produce grandi guadagni, concentrati in poche grandi produzioni e siti aggregatori. Ma vedremo come si svilupperanno le prossime puntate di quello che si profila come una piacevole scorribanda nelle nostre umane debolezze.