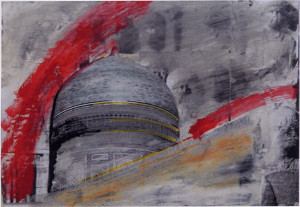ZY/H308 si trovò un pò smarrito all’esterno della sua astronave… Veramente non era un’ astronave, e nemmeno uno di quei patetici dischi volanti frutto della primitiva immaginazione terrestre. Era… bé, non essendo uno specifico scrittore di fantascienza, mi risparmierò e vi risparmierò elencazioni e dettati tecnici praticamente intraducibili. Perciò ritorniamo a ZY/H308…
Veramente quella era soltanto la sua sigla in codice, il suo vero nome, per così dire di battesimo, era una lunga sequenza di suoni più o meno gutturali: GUSGRUPUMSRAUGHAMRAM… ecc.ecc. Meglio lasciar perdere anche i nomi propri.
E se lo chiamassimo semplicemente e platealmente “l’alieno”? Fatto. Dicevo, l’alieno smarrito di trovarsi solo, lontano dai suoi compagni in territorio barbaro e sconosciuto, era però conscio dell’importanza del suo compito: infiltrarsi nella comunità indigena e raccogliere più notizie possibili. Il suo aspetto era quello., precisato nei particolari dall’esperto in terrestrità, il compagno XK/N222, l’aspetto di un invidiabile borghese benestante, diciamo molto benestante, di mezza età. Non si era badato al risparmio: elegante completo scuro di Armani, scarpe mocassino di morbida pelle fatte a mano, camicia di seta, orologio Baume—Mercier, abbronzato, slanciato, atletico.
Sarebbe stata la mimetica giusta per non dare nell’occhio? (Su tutte le riviste terrestri studiate gli indigeni si riparavano così dalle intemperie ).
L’alieno non fu più così sicuro di passare inosservato una volta che si inoltrò nel paesino di Combosar, sperduto tra le valli autunnali delle catene montuose. I pochi paesani sgranavano gli occhi (sopratutto le grasse paesane) come se avessero visto il nostro con la sua autentica faccia a sei occhi e le sue normali quattro braccia disarticolate. L’alieno maledisse in cuor suo lo “specialista” di bordo che l’aveva conciato così, pronto da spedire in bocca ai terrestri. Quel buon diavolo di XK/N222 pensava forse di spedire su per la Quinta strada di New York o a Piccadilly Circus di Londra il nostro alieno, ma quell’elegantone fascinoso, una specie di star del cinema, sembrava proprio cascato dal cielo in quelle quattro stradine fangose di campagna. Il nostro ospite vide comunque una specie di locale pubblico; entrò e si accomodò al bancone poi, seguendo a memoria le istruzioni filmiche terrestri, disinvoltamente tirò fuori dal pacchetto in dotazione una sigaretta e l’accese. L’uomo del bar gli si avvicinò e gli sorrise accattivante: “Mi dispiace signore, ma è vietato fumare nei locali pubblici!” L’alieno spense la sigaretta sempre più irritato con chi non ne aveva imbroccata una delle sue istruzioni! “Potrei avere dello champagne ben fresco?” L’uomo ridacchiò guardandosi intorno: “Champagne monsieur! Qui non siamo a Parigi!
Credo di averlo visto solo nei film lo champagne, giù in città!” ZY/H308 si morse ancora di nascosto le labbra e, come si dice, tagliò corto: “Che avete da bere qui?” — “Birra e grappa” — “Va bene!” L’uomo gli portò un bicchierino e una birra chiara: “Beva prima la grappa e di sopra ci butti la birra, glielo consiglio, è la nostra specialità”. Il nostro bevve e pensò che era ora di far domande: “Amico, c’e un albergo qui per poter dormire?
Ho lasciato l’auto fuori del paese. inservibile. Ho voglia di lavarmi e di dormire un pò”.
L’uomo ridacchiò di nuovo, e con una certa inquietante confidenza disse: “Niente albergo a Combosar. Abbiamo pochi turisti qui. Ma in quanto a dormire dormirai quanto vorrai con quello che ti ho fatto bere.
Eh, un bel galletto come te è raro da queste parti sarà bello spennarti!
Alla tua macchina penseremo domani… Buon riposo”.
ZY/H308 si girò di scatto: nel locale erano entrati quattro robusti montanari e gli erano intorno. La mano già irrigidita non riuscì a impugnare la pistola a ioni alternati.
Prima di chiudere gli occhi fece in tempo a pensare : “Maledetto XK/N222, imbecille… dove cazzo mi hai mandato?” Veramente non disse proprio così ma usò una frase della sua gente piuttosto greve e colorita che non oseremo tradurvi…