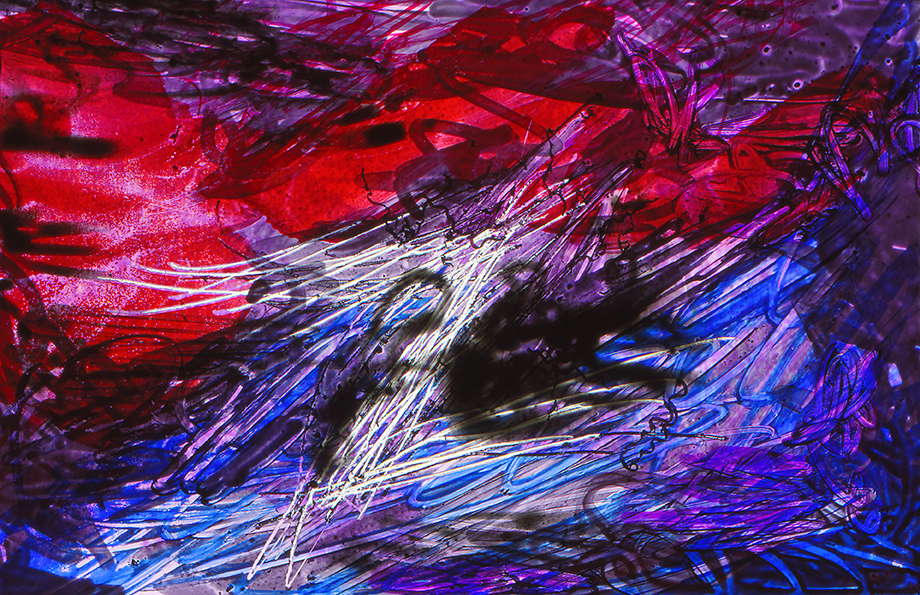
Stavo consultando una tesi di dottorato: Pluralismo tra democrazia e autoritarismo: il caso russo, di Laura Petrone. Liberamente scaricabile dalla rete (1), risale al 2010 ma resta attuale per capire quello che in questi giorni di guerra ci chiediamo tutti: come mai la Russia dopo la caduta dell’Unione Sovietica non si è evoluta come tutti avremmo sperato, cioè sviluppando istituzioni democratiche che non fossero formali ma garantissero uno sviluppo ideologico ed economico adeguato alla modernità? Lo scrivo in un momento in cui ci chiediamo, esterrefatti e inorriditi, come mai c’è ancora in Europa chi è convinto che obiettivi politici di egemonia non possano essere conquistati con pressioni politiche, diplomatiche e strategie economiche piuttosto che con la guerra, visto che nei conflitti moderni il costo è maggiore dei risultati e che pratiche forse normali nelle guerre antiche sono ormai inaccettabili?
Sicuramente c’è stata da parte del “pensiero occidentale” la convinzione che i regimi totalitari prima o poi crollino per evolversi verso una democrazia, con traiettorie abbastanza ordinate e prevedibili verso regimi democratici nati da elezioni libere e regolari. Determinismo peraltro simmetrico del pensiero totalitario, che ritiene la democrazia un disordinato contrattempo prima dell’affermazione di una struttura di potere non condizionata dall’equilibrio obbligato dalle dinamiche sociali ed elettorali. E qui mi andrei a rileggere Miseria dello storicismo di Karl Popper: l’evoluzione politica non segue mai strade obbligate: “nessuna società può predire scientificamente il proprio futuro livello di conoscenza”.
Ma torniamo alla Russia. In sostanza, ai tempi dell’Unione Sovietica, Stato e Partito (PCUS) facevano tutt’uno e Michail Gorbačëv (amato più da noi che dai Russi) cercò a suo tempo di riformarne le strutture, dando più importanza a quelle economiche che a quelle democratiche, indebolendo di fatto lo Stato. Lo scioglimento del PCUS imposto nel 1991 da Boris Eltsin spezzò questo binomio, col risultato di far indebolire le strutture statali a vantaggio di una classe di capitalisti che nelle privatizzazioni dei grandi enti di Stato trovarono la miniera d’oro, creando in un paese socialista una distopica sperequazione di ricchezza fra oligarchi e gente comune, resa possibile dall’indebolimento delle strutture statali e da connivenze criminali, fino all’ascesa di Vladimir Putin, il quale ha perseguito un fine solo: la restaurazione dello Stato come supremo organizzatore della vita civile, dell’economia e della politica. In sostanza è comunque lo Stato il garante che permette lo sviluppo di un regime democratico, e non per niente le democrazie occidentali si sono sviluppate quando lo Stato moderno ha definito e consolidato le sue funzioni (economiche, fiscali, militari, assistenziali, etc.) e dalla lotta politica si è creato un equilibrio fra i soggetti sociali rappresentati in un Parlamento. Non per niente i paesi ex-socialisti che hanno saputo creare una democrazia parlamentare (Polonia, Ungheria, i Paesi Baltici, Cechia) si basavano su esperienze storiche consolidate, mentre la Russia e le repubbliche sovietiche asiatiche (Kazakistan, Tagikistan) ne mancavano totalmente. Ma in Russia, dopo la debolezza dell’esecutivo a fronte dei poteri costituzionali e l’intreccio tra la sfera pubblica e la sfera privata tipica del tempo di Eltsin, Putin si è posto come priorità la ricostruzione dello Stato, dando più potere al centro attraverso una serie di riforme federali, riallineando con le buone o le cattive maniere gli oligarchi alla politica presidenziale, e di fatto burocratizzando l’élite politica. Il livello di obbedienza all’interno dell’apparato statale è tuttora alto, in più c’è l’ autosufficienza economica e finanziaria, ovvero il controllo statale sui proventi garantiti dalla vendita di risorse naturali come il petrolio e il gas, come ben sappiamo. Burocrazia qui va intesa in senso lato, come logica dell’organizzazione politica su larga scala. Questo recupero della centralità dello Stato non ha però incoraggiato né lo sviluppo di quelli che chiamiamo corpi intermedi (classe media, partiti politici rappresentativi) né il pluralismo. E’ un regime che di fatto unisce caratteristiche sia democratiche che autoritarie e propone un proprio modello di sviluppo politico-istituzionale alternativo a quello delle democrazie liberali. Al suo interno i valori democratici non costituiscono una priorità, in quanto subordinati all’imperativo di uno Stato forte e centralizzato. In questa logica si collocano provvedimenti quali la limitazione dell’autonomia dei poteri regionali, l’eliminazione dei governatori eletti dal Consiglio Federale, l’allontanamento dalla politica dei partiti non legati al Cremlino e alcuni interventi tesi a preordinare e regolamentare i confini della c.d. “società civile” attraverso un controllo delle principali fonti della contestazione politica. Anziché imporre un unico sistema filosofico-spirituale alla società nel suo insieme, lo Stato mette a disposizione un ventaglio di orientamenti accettabili, tra i quali la popolazione è libera di scegliere. Nella prassi si nota però il ricorso a forme di controllo autoritario non coercitivo, che vanno dalla frode elettorale all’intimidazione (o peggio) e cooptazione dei principali avversari politici come base del consenso sociale e del proprio potere. Diversamente dalle forme classiche di autoritarismo, l’apparato ideologico è scarno, lo vediamo in questi giorni, basato su un forte richiamo all’identità nazionale e sulla mancanza di alternative credibili, alle quali però non è stata data ancora occasione di crescere.
In questa prospettiva, il quesito più urgente non è perché la Russia non è democratica e cosa debba fare per esserlo, ma un altro: in quanto autocrazia, può essa affrontare le sfide dello sviluppo economico e della modernizzazione? Può vincere una guerra più lunga del previsto senza sfaldare la base del consenso popolare, per non parlare dell’economia, visto che il PIL russo è inferiore a quello italiano?
Note
- file:///C:/Users/Utente/Documents/Documenti%20scaricati/Geopolitica/Petrone_Laura_Tesi_dottorato(1).pdf .
Bologna, Facoltà di scienze politiche, 2010.

 La nuova Cortina di Ferro all’interno dell’Unione europea vede ampliarsi il Gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) con lo spostamento a destra dell’Austria e che farà muro contro l’impennata d’orgoglio dell’Ue nell’attivazione delle procedure previste dall´Articolo 7 dei Trattati, quando si riscontrano delle violazioni gravi di uno Stato membro, la Polonia, dei valori fondamentali dell’Unione.
La nuova Cortina di Ferro all’interno dell’Unione europea vede ampliarsi il Gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) con lo spostamento a destra dell’Austria e che farà muro contro l’impennata d’orgoglio dell’Ue nell’attivazione delle procedure previste dall´Articolo 7 dei Trattati, quando si riscontrano delle violazioni gravi di uno Stato membro, la Polonia, dei valori fondamentali dell’Unione.
 “
“
 Rispondendo agli allarmati quesiti della stampa internazionale, a ridosso dell’assassinio di Caruana Galizia, il premier maltese Muscat aveva promesso solennemente di far luce sull’efferato delitto. Quindi invitava i familiari ad aver fiducia nella giustizia. Sdegnata e ferma era giunta la risposta dei figli Mattew, Andrew e Paul. In un comunicato diffuso tramite i social media chiedevano le dimissioni del primo ministro e del suo staff, chiosando: “Chi per tanto tempo ha cercato il silenzio di nostra madre non può ora offrire giustizia”. E ancora: “Non siamo interessati a una giustizia senza cambiamenti. Il governo pensa solo a una cosa: la sua reputazione e ha bisogno di nascondere il buco dove son finite le istituzioni. Non è questo il nostro interesse, né era quello di nostra madre. Un governo e una polizia che hanno fallito nella difesa della vita di nostra madre, falliranno anche nell’indagare sulla sua morte”. Ieri una parte della società maltese ha ribadito il concetto manifestando in strada, come avevano già fatto venerdì scorso i colleghi di Daphne. Un corteo composto, ma determinatissimo s’è diretto sotto il quartier generale della polizia a La Valletta. Ha richiesto a gran voce e, poi leggendo un comunicato, le dimissioni dell’attuale capo della polizia, Lawrence Cutajar, e l’elezione di un nuovo rappresentante per dirigere le indagini assieme alla magistratura.
Rispondendo agli allarmati quesiti della stampa internazionale, a ridosso dell’assassinio di Caruana Galizia, il premier maltese Muscat aveva promesso solennemente di far luce sull’efferato delitto. Quindi invitava i familiari ad aver fiducia nella giustizia. Sdegnata e ferma era giunta la risposta dei figli Mattew, Andrew e Paul. In un comunicato diffuso tramite i social media chiedevano le dimissioni del primo ministro e del suo staff, chiosando: “Chi per tanto tempo ha cercato il silenzio di nostra madre non può ora offrire giustizia”. E ancora: “Non siamo interessati a una giustizia senza cambiamenti. Il governo pensa solo a una cosa: la sua reputazione e ha bisogno di nascondere il buco dove son finite le istituzioni. Non è questo il nostro interesse, né era quello di nostra madre. Un governo e una polizia che hanno fallito nella difesa della vita di nostra madre, falliranno anche nell’indagare sulla sua morte”. Ieri una parte della società maltese ha ribadito il concetto manifestando in strada, come avevano già fatto venerdì scorso i colleghi di Daphne. Un corteo composto, ma determinatissimo s’è diretto sotto il quartier generale della polizia a La Valletta. Ha richiesto a gran voce e, poi leggendo un comunicato, le dimissioni dell’attuale capo della polizia, Lawrence Cutajar, e l’elezione di un nuovo rappresentante per dirigere le indagini assieme alla magistratura.