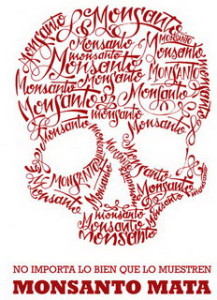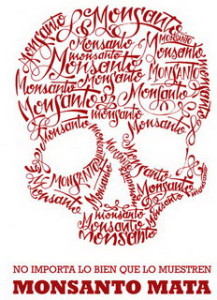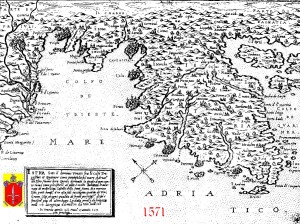Nella corsa allo sviluppo e nel tentativo di emancipazione dall’influenza nordamericana, archiviando la cosiddetta dottrina Monroe, i paesi sudamericani hanno spinto sulla crescita economica attraverso processi di industrializzazione e di costruzione di grandi opere nei quali, spesso, si sono manifestate evidenti contraddizioni in termini di violazioni ambientali e di diritti umani.
Stiamo parlando di un territorio – quello sudamericano – che concentra in sé quasi la metà delle foreste tropicali e sette dei venticinque ecosistemi più ricchi del mondo. È popolato da oltre cinquecentoventidue gruppi indigeni rappresentanti però, solo il 6% della popolazione totale, che invece si riversa negli agglomerati urbani (dopo il 1960 il tasso di urbanizzazione passa dal 50% al 75%) posizionando quindi tale Continente come il più urbanizzato del terzo mondo (il 30% della popolazione concentrata nelle periferie).
La costruzione di accessi di comunicazione terrestri o per acqua, il disboscamento, l’urbanizzazione, l’estrazione delle materie prime (minerali e idrocarburi), la coltivazione dei campi con monocolture intensive, la pratica della caccia (47 % delle specie animali sono catturate illegalmente), la promozione del turismo o la creazione di impianti industriali, se non affrontati in un’ottica ecosostenibile, creano danni non solo al territorio circostante ma di seguito al paese e conseguentemente all’equilibrio ecologico mondiale.
Ciò è facilmente intuibile soprattutto nel caso della deforestazione, che ha causato nel continente latinoamericano tra il 1990 e il 2000 la perdita di 46,7 milioni di ettari di foreste e avanza, con una percentuale annuale doppia rispetto alla media mondiale, contribuendo così in modo sostanziale al cambio climatico e all’effetto serra.
Necessita invece di una maggiore riflessione l’analisi delle conseguenze relative allo sfruttamento dei campi per le monocolture e per i biocarburi, come avviene nel primo caso, nel “blocco” costituito da Argentina, Brasile, Paraguay e Bolivia che rappresenta il 68% dell’esportazione mondiale complessiva della soia e si sta affermando come il maggiore esportatore mondiale di questo cereale (“Mercosoya 2006”) e nel secondo, con la coltivazione della canna da zucchero in Brasile.
La monocultura, agroecologicamente parlando, nega la possibilità dello sviluppo di un’agricoltura adattata al ciclo biogeochimico terrestre comportando, quindi, un alto supporto di fertilizzanti, erbicidi, fungicidi i cui residui contaminano ed inquinano il territorio coltivato. L’intensificazione delle monoculture e dell’allevamento bovino in zone ecologiche, come ad esempio quella del “Cerrado” e del “Chaco”, hanno causato la perdita delle caratteristiche ecologiche del territorio e delle riserve naturali di biomassa. All’impatto ecologico si aggiunge quello sociale derivato dalla riduzione dei campi disponibili per la produzione di alimenti.
La costruzione dell’autostrada trans-amazzonica e dell’idrovia Paraguay-Paranà hanno anch’essi influito sulla perdita della biodiversità.
Nella ricerca di fonti di energia alternative, obiettivo di per sé pregevole, il Brasile ha progettato di costruire una diga per la quale verrà modificato circa l’80% del corso del fiume Xingu, danneggiando di conseguenza gli abitanti di quell’area che verranno a trovarsi senza acqua. Peraltro, secondo studi dell’ INPA (Istituto amazzonico nazionale di ricerca), l’inondazione della foresta causerà la dispersione in atmosfera di enormi quantità di metano, un gas serra che è venticinque volte più dannoso dell’anidride carbonica.
Il rispetto ambientale è negato di fronte al miraggio dei profitti anche quando si parla di multinazionali nordamericane o europee operanti in territorio sudamericano. Alla luce del fenomeno già ampiamente dibattuto “del nuovo colonialismo economico” perpetuato dalle multinazionali, queste ultime hanno praticamente invaso i paesi in via di sviluppo, per sfruttare nuovi giacimenti minerari e d’idrocarburi e godere di enormi vantaggi, sia di tipo economico che tecnico: come la deregolamentazione sulle tematiche ambientali. Questo ha portato, proprio in America Latina, ad un aumento esponenziale della presenza di industrie estrattive che non hanno avuto scrupoli ad usare metodi poco ortodossi, a volte anche all’oscuro dei governi, e che molto spesso restano impunite.
Ma alcuni casi vengono alla luce: come quello della lunga battaglia legale tra Chevron e gli ecuadoriani. Fortunatamente la Corte Suprema statunitense ha respinto la richiesta della Chevron per l’annullamento della sentenza ecuadoriana che richiede un risarcimento di 18,2 miliardi di dollari, emessa nel 2011 dopo 8 anni di indagini nella città petrolifera di Lago Agrio. L’Ecuador ha dimostrato che erano stati versati più di 16 miliardi di galloni di greggio, fanghi e rifiuti tossici in Amazzonia, gravemente inquinanti per sorgenti, falde e corsi d’acqua e, a causa dei quali, sono state decimate tribù indigene della regione.
Una battaglia è stata vinta “penso che sia stata fatta giustizia”, afferma il presidente dell’Ecuador Rafael Correa, anche se come ha affermato la Corte d’appello “nessuna somma sarà sufficiente a riparare tutti i crimini che hanno fatto nella nostra zona, né sarà sufficiente a portare i morti in vita.”
Lo stesso Correa che intende affidare lo sfruttamento di una zona della foresta amazzonica ai cinesi, disinteressandosi degli indios che vi abitano.
La Cina è bramosa di ricchezze naturali e dopo l’Africa è la volta del continente latinoamericano ad essere visto solo come uno smisurato supermercato per soddisfare tutte le nessità di una popolosa nazione protesa ad acquisire il monopolio di ogni risorsa, in una sorta di Capitalismo di Stato autoritario globale.
Un’avidità che ha portato la Cina alla devastazione di parte del suo territorio e di quello africano per impegnarsi anche sul suolo sudamericano.
Nel caso della Famatina (Argentina, estremo nord della provincia di La Rioja) è la piccola comunità e non il Governo a lottare contro la corporation canadese Osisko Mining sensibilizzando l’intero paese fino a mobilitare manifestazioni davanti all’ambasciata canadese di Buenos Aires. La comunità della Famatina è riuscita, per il momento, a bloccare l’estrazione di oro nella megaminiera a cielo aperto: la multinazionale canadese utilizzava 10 tonnellate di cianuro al giorno per separare l’oro dalla roccia, con effetti devastanti non solo per la contaminazione dell’acqua della zona ma anche per tutto il territorio.
Come afferma Gustavo Carrasquel, ambientalista venezuelano: ”Oggi non c’è un governo in America Latina che stia realmente costruendo un progetto per il miglioramento delle condizioni ambientali nel proprio paese”.
C’è comunque da dire che ripercorrere il tema ambientale ed i principi dello sviluppo sostenibile, creando obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, implica il tenere in considerazione le minacce o gli impatti ambientali in eco-regioni (178 “ecoregioni” identificate in America Latina e Caraibi) per lo più sovranazionali.
Veri e propri conflitti tra gli interessi del Capitale e quello delle comunità, non solo indigene, custodi di aree preziose a preservare le biodiversità, evidenziati nel sito della CDCA (Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali).
Le logiche dello sviluppo sostenibile seguono un’intricata rete di attori e problematiche, difficilmente rappresentabili in un quadro organico. Da qui la grande complessità e la necessità di promuovere un Piano di Azione Sovranazionale con un Fondo monetario ad esso univocamente destinato per bilanciare economie e diseconomie. È importante, altresì, una maggiore sensibilizzazione non solo a livello nazionale (pensiamo semplicemente alla gestione dei rifiuti nel territorio urbano), ma anche internazionale.
Nell’ambito delle Istituzioni a tutela o dei tavoli aperti dalle varie organizzazioni, l’approccio latinoamericano è caratterizzato da forme di integrazione sub-regionale e da una marcata tendenza al metodo intergovernativo, piuttosto che allo sviluppo di istituzioni sovranazionali.
Organizzazioni “storiche” come il Mercosur, la Comunità Andina delle Nazioni (CAN) e il Sistema dell’Integrazione Centroamericana (SICA), ma anche le nuove come l’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR) e l’Alternativa Bolivariana per l’America (ALBA), coinvolgono aree più limitate rispetto alle grandi aggregazioni geografiche: un quadro composito di integrazione nel quale coesistono diversi raggruppamenti di paesi che rende difficile il perseguimento di politiche che coinvolgano efficacemente anche dimensioni extra regionali.
In questo panorama si inserisce la Conferenza sulle strategie per l’uso delle risorse naturali (Conferencia de la Unión de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales para el Desarrollo Integral de la Región) che riunirà dal 27 al 30 maggio nella capitale venezuelana i membri dell’UNASUR. Una riflessione collettiva sull’importanza di un migliore utilizzo delle risorse naturali e del territorio, per uno sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico, culturale, tecnologico e industriale.
I governi sudamericani saranno sufficientemente lungimiranti nelle scelte?