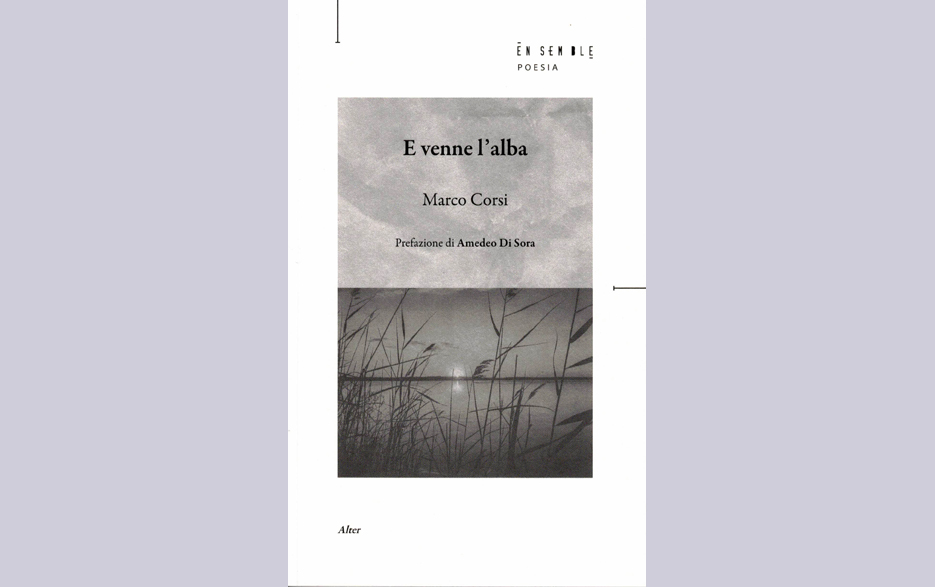Il 2023 si è concluso con numerosi conflitti attivi, un elenco preciso è difficile e varia da fonte a fonte e non ci sono solo l’aggressione russa all’Ucraina e Hamas – Israele, ma anche la guerra civile in Sudan e quella dello Yemen, solo apparentemente in standby sospesa per intrufolarsi tra quella di Hamas e Israele.
Altri conflitti, alcuni dei quali sono guerreggiati, dimenticati e a “bassa intensità”, dove si vedono non solo missili e dromi o cannoni e mitragliatori , ma anche fucili e pistole, lance e frecce, sino a machete e coltelli, circoscritti in piccole aree per il predominio sulle ricchezze naturali o per far prevalere gli interessi degli allevatori su quelli degli agricoltori, ma in ogni caso le vittime sono sempre le stesse: bambini e donne, ma anche operatori umanitari e dell’informazione.
Conflitti che possono variare da una sessantina a qualche migliaio, se si conteggiano anche eventi violenti che sporadicamente tuonano ad insanguinare le strade per motivi politici, religiosi e tribali, secondo le fonti come: ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), Sipri (Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma) e l’Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo.
L’Etiopia, la regione africana del Sahel, il Mali, la Somalia, la Repubblica Democratica del Congo, la Nigeria, il nord del Mozambico, l’Afghanistan, il Libano, Haiti, il Messico, la Colombia, lo Myanmar, tra India e Pakistan per il Kashmir, gli armeni e gli azeri, i russi e i georgiani, per non dimenticare la Siria e il governo turco contro i curdi.
Un Mondo in balia degli estremismi che si nascondono tra credi ed ideologie, ma in realtà sono solo avidi di potere e bramosi di possedere ciò che non gli appartiene, creando flussi migratori.
Ci sono migranti e migranti, come ci sono profughi e profughi, con una speranza che non trova spazio in un Mondo costruito sugli egoismi, dove quello che è mio rimane mio e quello che è tuo dovrebbe diventare mio.
Nel mondo esiste l’odio e se non c’è l’amore certamente non c’è l’empatia che può avvicinarci all’altruismo.
Usare le parole in modo inconsapevole o addirittura in mala fede possono essere un linguaggio d’odio, per questo la “Carrara di Roma”, come più recentemente Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio, indica l’uso corretto dei vocaboli e il loro contesto quando si parla di migranti.
Persone che vivevano assediate ed ora assediano, cacciati che ora praticano pulizie etniche, perché dei fanatici ritengono incompatibile la convivenza tra “differenti” culture.
Conflitti che nascono per combattere i “cattivi”, ma in realtà per nascondere che “l’erba del vicino è sempre più verde” e solo perché qualcuno vuole qualcosa che qualcun altro ha.
Sono lontani i tempi nei quali si rideva dell’esorcizzazione del possesso con il film di Stanley Donen, L’erba del vicino è sempre più verde, dove Cary Grant “ha” ciò che Robert Mitchum vuole e con il ruolo politicamente scorretto di Deborah Kerr nel ruolo dell’erba più verde.
Non possiamo soccombere alla prepotenza se non per noi almeno per chi non può difendersi creando le condizioni per scardinare l’invidia.
A molti manca quel coraggio in più dalle donazioni alle organizzazioni umanitarie che oltre a mitigare i sensi di colpa fa dispetto a quella destra incapace di empatia offrendo un impegno diretto verso gli ultimi.
L’Arte non avrà la capacità di difendere l’umanità dalla crudeltà ma può far riflettere sulle diseguaglianze e fare da megafono ai giornalisti che fanno giungere oltre le aree di conflitto l’invocazione di un ragazzo dai fieri occhi azzurri, del suo “non ho paura, ma voglio vivere. Portatemi via di qua”.
L’Arte ha il compito di seminare dubbi e far riflettere sulle contraddizioni e le diseguaglianze che affliggono il Mondo e far dialogare le persone impegnate per la Pace.
Un’Umanità vittima della fuga dai conflitti e dalle carestie e obbligata a migrare dove la speranza di trovare un luogo per vivere per migliaia di persone naufraga in mare o nei deserti, nelle foreste o davanti al filo spinato di un confine.
Secondo il Mid-Year Trends Report dell’UNHCR (l’Alto Commissariato ONU per i diritti dei rifugiati), sono oltre 100milioni le persone che fuggono dai conflitti.
Come scriveva Italo Calvino “L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.” (Le città invisibili).
È un inferno dove fanatici estremisti vengono manipolati da chi ha come unico interesse il profitto, sfruttando la Natura e le Persone. Individui in cerca di profitto ad ogni costo, spesso nascosti dietro a rassicuranti elogi della Pace.
Dovrebbe essere possibile emarginare e sconfiggere i fanatici dediti a far soffrire gli estremisti che vogliono comandare. Due entità che fanno gli interessi di chi opera scommettendo sulle disgrazie altrui.
Conflitti che si protrarranno per anni se non si troveranno soluzioni diplomatiche o “non perderà” chi resisterà di più.
L’Onu come Unione Europa, i vari stati e organizzazioni sbandierano la Carta dei Diritti Umani, ma sono diritti che non valgono per tutti. Governi che accusano altri governi di violare i Diritti e la storia si ripete con il bue che da del cornuto all’asino.
Anche la nostra Costituzione, all’Articolo 2, sancisce che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”, come ha tenuto a ricordare il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, oltre al consigliare di praticare la gentilezza, dando il buon esempio, affermando anche che “La guerra genera odio, serve cultura di pace” e ai giovani in particolare: “L’amore non è possesso” e “La democrazia è voto e non sondaggio”, è partecipazione come cantava Giorgio Gaber.