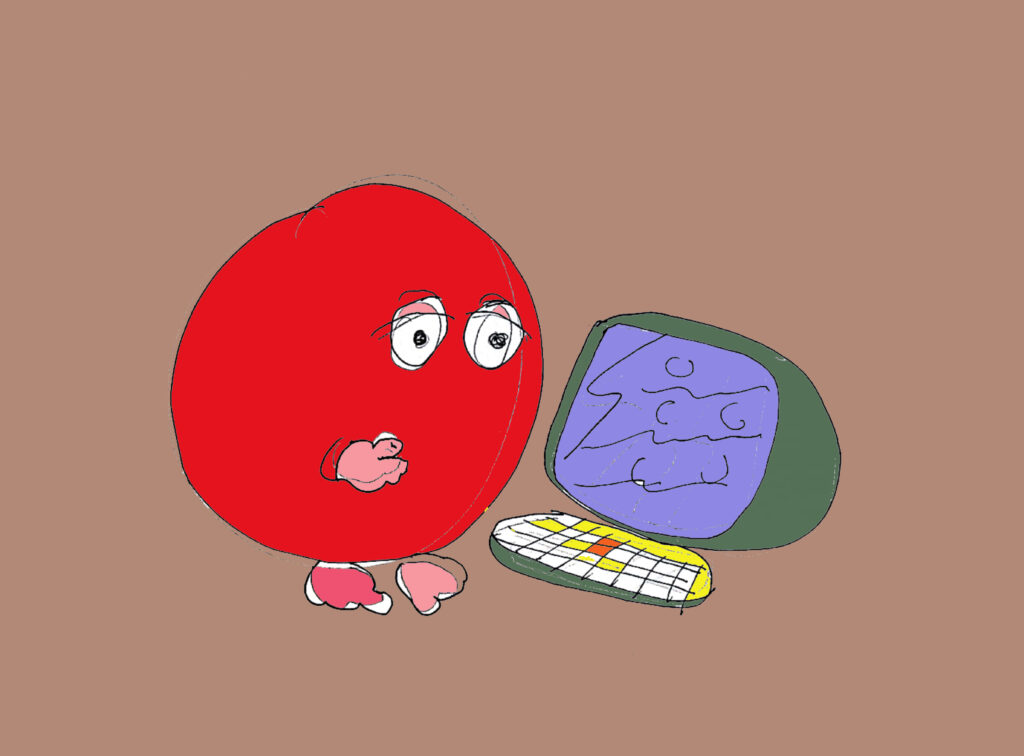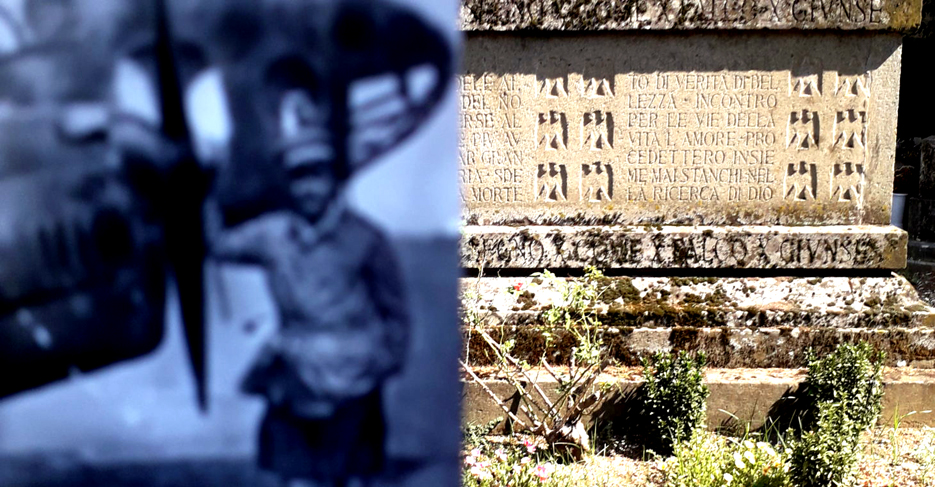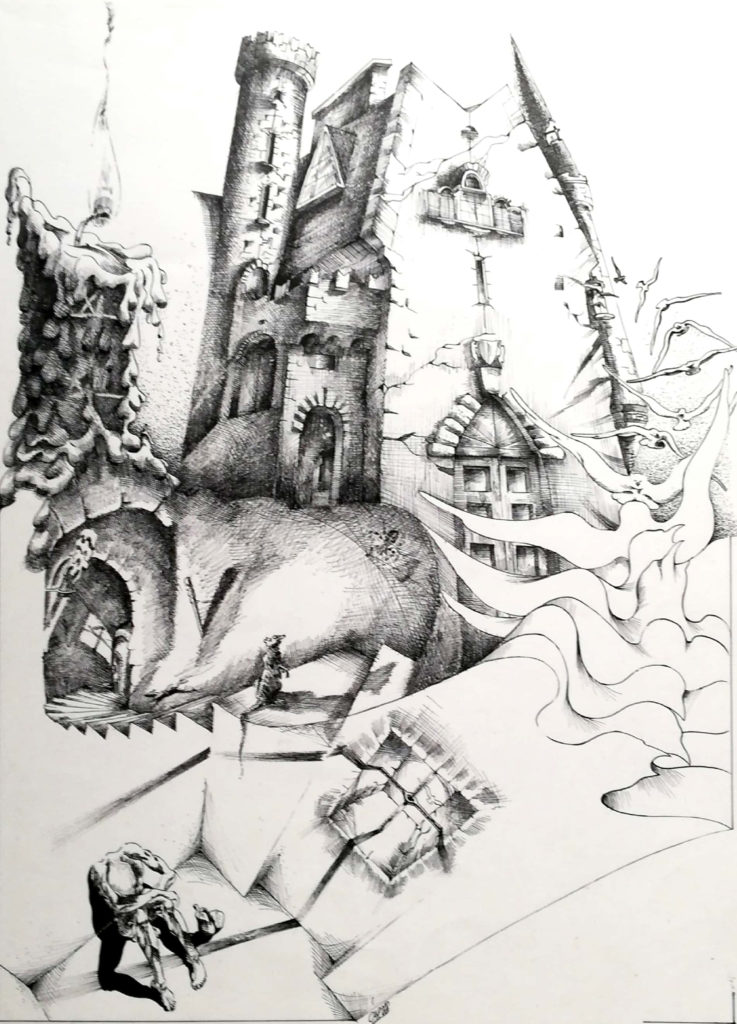E’ ufficiale: la scrittura lineare Elamita è stata parzialmente decifrata. A farlo è stato un archeologo professionista francese e i risultati sono stati presentati ufficialmente all’Università degli studi di Padova, in attesa di essere discussi sulle riviste scientifiche specializzate. Lo scrivo perché troppe volte avventurieri dell’archeologia si sono svegliati una mattina con la chiave per decifrare lingue e scritture antiche, fosse l’etrusco o il disco di Festo. L’archeologo francese François Desset è invece uno specialista ancora giovane (38 anni), ha un incarico all’Università di Lione; il problema lo studiava dal 2008, ed è il primo a dire che ci vorranno almeno altri quattro anni per decifrare in parte la quarantina di iscrizioni “elamite” (il nome è convenzionale) a noi rimaste. Si tratta di una civiltà della penisola iranica parallela al mondo assiro-babilonese ma linguisticamente ed etnicamente diversa e isolata, fiorita 3-4000 anni fa. Le iscrizioni studiate risalgono al 1950 a.C. circa e hanno l’insolita caratteristica di essere stilate in una scrittura completamente fonetica: a ogni segno grafico cioè corrisponde un suono (meglio: un fonema) e i segni sono un centinaio, quindi molti sono sillabici (come nell’alfabeto etiope). Una stranezza, visto che le scritture antiche, come il geroglifico egiziano e il cuneiforme assiro, sono inizialmente logografiche (ai segni corrisponde un oggetto o un concetto) e solo più tardi si evolvono in senso fonetico. Tanto per fare un esempio, il disegno di una nave significa appunto “nave”, ma più tardi può indicare il fonema “na” o la lettera “n”. Quanto al sistema pensato da Desset, è analogo a quello usato a suo tempo da da Champollion – un altro francese – per decifrare i geroglifici egiziani al tempo di Napoleone: identificare il nome del Re. Lo stesso fece il tedesco Grotefend, il quale identificò i nomi degli imperatori persiani Dario I e Serse nelle iscrizioni cuneiformi di Persepoli e Bisitun. Solo che nell’elamitico questi nomi non erano racchiusi in un cartiglio come nella Pietra di Rosetta, quindi l’operazione ha richiesto più tempo. Ma una volta raggiunto questo primo obiettivo, è stato più facile decifrare il resto, tenendo presente che nei documenti antichi la scrittura era destinata alle operazioni amministrative (come nella Lineare B cretese, su cui torneremo) o alle dediche formali. In questo caso le frasi ricorrenti sono del tipo “io XY, figlio del re XZ..”, “questo tempio è stato dedicato da…” “offerta in onore del dio YZ…”, quindi alla fine sono anche ripetitive, come certe iscrizioni funerarie etrusche che alla fine dicono sempre le stesse cose. Solo più tardi viene messa per iscritto la letteratura, ma dopo secoli di trasmissione orale; esempio classico: i poemi omerici.
Decifrare le scritture antiche è sicuramente una sfida appassionante, ma richiede metodo scientifico. La Lineare B cretese fu decifrata da Michael Ventris insieme a John Chadwick. nel 1952 e ancora c’è chi pensa trattarsi di due archeologi dilettanti, complice una certa stampa divulgativa. In realtà Chadwick era un glottologo e Ventris un giovane matematico e crittografo. Quindi non un dilettante, ma un geniale professionista prestato all’archeologia. E anche in questo caso c’erano anni di studio sistematico della documentazione, in questo caso composta da centinaia di tavolette di terracotta incise, contenenti atti amministrativi del potere miceneo. La lingua fu dimostrata essere un greco arcaico, una lingua cinquecento anni più antica di quella di Omero e spesso trascritta in forma abbreviata, ma comprensibile. Resta però ancora da decifrare la Lineare A, più antica, scritta in una lingua diversa ma con segni talvolta simili. Ma sicuramente anche qui si tratta di documenti amministrativi.
Una volta stabilito il verso della scrittura e sempre che un testo sia leggibile (non solo lo stato di conservazione spesso è un problema, ma troppe volte le parole sono scritte una attaccate all’altra), un problema è costituito dal numero e lunghezza dei testi: più i testi sono numerosi e lunghi, più facile è affrontarli. L’etrusco p.es. ci ha lasciato tanti testi leggibili (l’alfabeto è noto) ma quasi sempre brevi e ripetitivi, essendo dediche funerarie. L’analisi linguistica è basata in sostanza su due parametri: l’occorrenza statistica di alcuni segni o gruppi di segni (che identifica parole o anche formule fisse) e la posizione di questi blocchi all’interno della serie di segni, ovvero quello che in linguistica si chiama sintassi. Nel primo caso possiamo anche andare oltre: se un blocco ricorrente ABC si lega spesso a suffissi o prefissi DF o GH, possiamo suggerire che queste particelle aggiungano senso alla parola centrale: potrebbero marcare aggettivi (p.es., matre-ma, “mia madre” in siciliano) o flessione (come nelle declinazioni latine: matri-bus, “alle madri”). La sintassi si occupa invece della distribuzione degli elementi all’interno del testo. Tenendo presente che tutte le lingue servono per comunicare e quindi sono macchine logiche, è altrettanto logico che stabiliscano il rapporto tra chi parla e il mondo esterno. Quindi, avremo un Soggetto che compie l’azione, un Oggetto con cui entrare in relazione e un verbo (magari sottinteso) che specifica che tipo di azione intendo fare: esprimere un possesso (verbo avere), un’identità (verbo essere) o un’azione (p.es., verbo fare, donare, etc.). Le disposizioni sono sempre quelle: Soggetto + Verbo + Oggetto (SVO) o Soggetto + Oggetto + Verbo (SOV). Il resto sono funzioni di valore aggiunto per indicare dove, come, quando. Ma ora c’è il computer.
L’idea alla base è quella di individuare le relazioni tra le parole mappando una lingua specifica. Serve un database di testo che permette al software di calcolare, per esempio, per ogni parola, quanto spesso essa si ripete accanto a determinati termini. Lo studio statistico di ogni singola parola permette di creare uno spazio multidimensionale con dei parametri che descrivono la sintassi della lingua in base a quel termine specifico. Il sistema non capisce il significato, per lui ogni frase è solo un insieme di vettori nello spazio che occupano gli stessi punti e ripetono il loro comportamento. Sovrapponendo le mappe “spaziali” di una lingua rispetto a una sconosciuta si possono individuare “pattern” simili e quindi tentare una traduzione.
Con i computer dunque ora è tutto più facile: anche i geroglifici sono stati codificati in codici alfanumerici per poter essere letti dalle macchine, e sono stati sviluppati algoritmi, usati ora nelle perizie di tribunali, capaci di scartare il testo di un contratto falso se divergente nella distribuzione di alcuni elementi o persino nella ricorrenza di gruppi ternari di lettere. Da notare che l’archeologia ormai si vale di tecnologie pensate per altri fini: l’analisi dei metalli era stata sviluppata per le perizie balistiche, ma ora anche l’archeologo per stabilire l’autenticità di un monile si appoggia ai laboratori della Polizia Scientifica.
I casi impossibili? Documenti scarsi di numero, brevi e scritti nell’alfabeto sconosciuto di una lingua sconosciuta. Stiamo parlando di una serie di iscrizioni e sigilli del’antica valle dell’Indo, miste pittografiche; del Meroitico (alta Nubia al confine col Sudan); di alcuni linguaggi precolombiani che sopravvivono nei dialetti locali; alcune iscrizioni c.d. “Rongo-Rongo” dell’Isola di Pasqua, affini per lingua alla locale parlata Rapanui. E in più un reperto che appassiona da anni studiosi e dilettanti: il Disco di Festo (o Festos), nell’isola di Creta. Su questo reperto esprimo i miei dubbi: è un documento unico, isolato e inciso su terracotta con punzoni metallici. Ufficialmente ha precorso i tempi di Gutemberg, ma trovo più logico che il falsario (l’archeologo Luigi Pernier?) abbia ingenuamente proiettato nei tempi arcaici la propria mentalità. E poi, se i punzoni servivano per produrre documenti in serie, dove sono finiti tutti gli altri? Sarebbe ora di rileggersi con cura il giornale di scavo della Missione italiana a Creta nel 1908 e cogliere le incongruenze del caso. Il falso non ha storia, esce sempre dalla nebbia e mescola allegramente elementi presi da altri modelli; ebbene, qui non manca niente per rientrare nella categoria, visto che molti simboli sembrano presi da altre culture e documenti. Ma passiamo al dettaglio di questo strano documento isolato: è una sorta di DVD di argilla cotta, fin troppo pulito e intonso, inciso su due lati con 241 simboli, spesso assiepati o mal allineati. I punzoni erano 45, probabilmente metallici. La distribuzione dei simboli fra le due facce è molto diseguale e solo questo mi fa pensare a un grossolano falso: tale divario non è coerente con la normalità di un testo. Se sono in sequenza, due pagine di un libro di preghiera o di un testo amministrativo non possono essere troppo diverse: è normale aspettarsi la continuità testuale e stilistica del testo unico.
E qui mi voglio divertire esponendo alcuni tentativi di decifrazione del disco di Festo, opera sia di noti archeologi che di fantasiosi dilettanti. Chi ha interpretato i segni come geroglifici, chi ha dato loro un valore fonetico sillabico, ma l’insieme è un autentico delirio:
- “Alla grande signora dei Keftiti, alla grande Atena dominatrice degli animali, sbaragliatrice egli Irafioti, Ronte, figlio di Danao asperse, Ronte nel tempio dei Keftiti, Ronte, figlio di Danao, asperse l’albero. Menafite, l’esperto sommo sacerdote, eliminò gli animali infetti e il giusto Radamante rese grazie alla dea Era”.
- “E’ stato decodificato di recente il disco di Festo,un disco di pietra di origine Atlantidea risalente al 1700 A.C in cui vi sono scolpiti in entrambi i lati dei simboli che fino ad oggi non si sapeva cosa significassero e si è scoperto che indicano la causa delle malattie genetiche per prevenirle e curarle. La decodifica è stata possibile con un antico testo etiope”.
- “Sei parole parlano di luce ed altri sei di luce del tramonto; tre parole parlano della Dea incinta mentre altre dieci attribuiscono vari epiteti alla Dea”.
- “Altri credono che contenga una storia di narrativa o d’avventura, oppure che si tratti di un gioco da tavolo o di un teorema geometrico”.
- “Fu fatto realizzare, per suo uso esclusivo, da una sacerdotessa cretese, dedita ai rituali sessuali, appartenente alla comunità sacerdotale di Malia. Il Disco veniva utilizzato una volta all’anno insieme alla Pietra di Kernos, oggetto circolare di circa 90 cm di diametro, con 34 vaschette lungo il perimetro: trentatrè della medesima dimensione e una più grande. Oggi si trova all’interno del sito archeologico di Malia, ovvero dove venne realizzata nel 2560 a.C. – Non di semi venivano riempiti gli incavi della Pietra di Kernos, ma di sperma: lo sperma di 34 giovani uomini appartenenti alla sopraccitata comunità di Malia”.
- “Partendo proprio dalla margherita al centro di una faccia del disco (…) è facile tradurre il disco di Festo che racconta una bellissima storia d’amore che si svolge sulle sponde del Mar Nero e lungo il percorso del fiume Istros, oggi Danubio. Un giovane principe del popolo dei Traci si innamora di una principessa lontana, la nobile Pellicana figlia del re dei Pelagi. Ad aiutarlo nell’intento di impalmare la giovane e bellissima principessa è lo stesso padre del principe. Con l’aiuto del nobile genitore e delle tribù dei Daci, raffigurati nel disco col simbolo dei lupi, e degli Apuli raffigurati col simbolo delle api, il giovane principe dopo varie peripezie riesce a sposare l’innamorata. Dalla coppia regale nasce un bellissimo figlio che dona letizia a tutta la nazione.
- “Analizzandone il testo, prende forma la consapevolezza che il cerchio voglia esprimere, rappresentare in maniera immediata e simbolica, conoscenze geo-matematiche che attengono alla figura. l Disco di Festo altro non è che un “normalissimo” calendario-diario ad uso e consumo, forse, dei giovani”
- “Beata dea del labirinto. Beata Isonoia, dea del destino e custode della casa che protegge il passaggio (all’al di là). La Creontide Daphne vi consacra a te – la Creontide, nell’inaccessibile del labirinto – la Creontide Daphne vi consacra a te la mummia di Maniaporte, esperta delle leggi e delle consuetudini nazionali dei popoli. Ti è stato massacrato dai reparti di Tideo, perciò è stato sposato alla forte Deione il celebrato Radamanto”.
Che dire? Il mondo è bello perché vario.