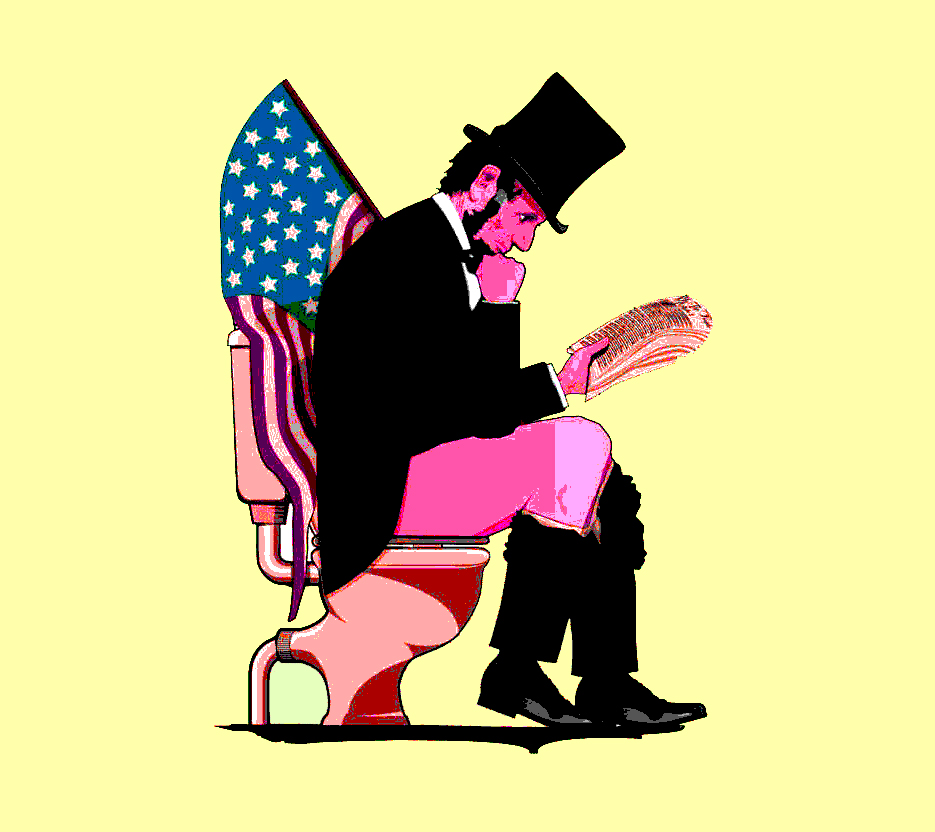Le elezioni politiche italiane e la formazione del nuovo governo nazionale a guida “giallo-verde” rappresentano un chiaro esempio di come lo scenario geopolitico mondiale stia mutando nella direzione della costituzione di nuovi equilibri internazionali. La crisi economica e l’incapacità della compagine politica di stampo moderato di fare fronte alle problematiche più impellenti di una società democratica in grave affanno sociale, economico e culturale quale è quella italiana hanno favorito la scalata verso il potere delle principali formazioni politiche di stampo populista, le quali sono infine riuscite a raggiungere i vertici dei palazzi istituzionali romani. L’utilizzo spregiudicato dei media sociali ha rappresentato l’elemento trainante di una propaganda “anti-sistema” che si è dimostrata a tal punto abile a manipolare ai propri fini la rete di internet da riuscire a fornire un supporto determinante ed indispensabile per la creazione di un inedito e vasto consenso elettorale a favore dei partiti che sostengono l’attuale maggioranza di governo. Non deve altresì sorprendere che sia la Lega che il Movimento Cinque Stelle si ricolleghino a vario modo ad una più ampia galassia di formazioni populiste di stampo “euro-asiatico” quali, ad esempio, quella di Marine Le Pen in Francia, Viktor Orban in Ungheria e Nigel Farage nel Regno Unito le quali, a loro volta e su vari livelli, sono riconducibili al più vasto sforzo politico-militare e mediatico della Russia di Putin, finalizzato primariamente ad accrescere la sfera di influenza russa sia sul continente europeo che in altre aree di crisi come il Medioriente.
L’esito delle elezioni italiane, tuttavia, non può non essere correlato con l’evento politico che ha rappresentato lo spartiacque fondamentale relativo alle più recenti relazioni in essere tra Occidente e Russia ovvero l’elezione alla Casa Bianca di Donald Trump. Il presidente Trump ed i suoi sostenitori, come noto, sono portatori di una subcultura fortemente “anti-establishment”, il che, a mano a mano che questi soggetti politici si sono infiltrati attraverso la società civile e hanno occupato i principali gangli del potere, li ha condotti in modo naturale a scontrarsi con quelle che erano le “casematte” degli apparati burocratici e governativi tradizionali. Non ci si deve pertanto stupire che Mosca abbia, al momento opportuno, colto l’opportunità di avvicinare i membri più influenti dell’entourage di Donald Trump in modo tale da favorire un candidato che avrebbe indotto gli Stati Uniti a compiere scelte politiche che con ottime probabilità sarebbero risultate assai vantaggiose per gli interessi domestici ed internazionali del Cremlino. In tal senso è noto quanto il controverso Steve Bannon abbia supportato l’affermazione dell’attuale compagine di governo italiana e quanta influenza Bannon possieda ancora in seno all’estrema destra americana, a tal punto da poter essere quasi considerato, nonostante i rapporti assai tesi nonché controversi con Trump, una sorta di agente provocatore itinerante dell’estrema destra “a stelle e a strisce”. La convergenza di interessi tra ultradestra americana, partiti populisti europei e l’agenda del Cremlino è fin troppo palese per essere posta seriamente in dubbio e la recente defenestrazione dal governo del presidente Usa di Rex Tillerson e H.R. McMaster rappresenta purtroppo la cartina di tornasole di quanto gli apparati burocratici tradizionali “a stelle e a strisce” ormai non siano più in grado di tenere a freno un Trump che si sta emancipando dalla tutela impostagli dagli apparati statali stessi e dalla classe politica americana più moderata all’indomani della sua elezione alla Casa Bianca. Lo strappo nel recente G7 in Canada con i principali alleati euro-atlantici e la quasi commovente “corrispondenza d’amorosi sensi” con il giovane dittatore nordcoreano Kim Jong-un testimoniano una volta di più la predilezione del presidente Usa per una gestione verticistica, autoritaria, istintuale nonché familistica della cosa pubblica. Donald Trump ha dimostrato di apprezzare in misura assai maggiore relazioni istituzionali ed umane con quella porzione di globo che l’Occidente ha sempre collocato fra i “paria” della comunità internazionale e questo nonostante il presidente stesso, coltivando tali sconvenienti simpatie, sia più volte caduto nel ridicolo a causa di relazioni interpersonali palesemente sbilanciate a favore della controparte di turno. Purtroppo il presidente degli Stati Uniti non sembrerebbe essere connotato solo da una mera disarmante ingenuità, al contrario appare così profondo il proprio risentimento nei confronti di un “establishment” che non ha affatto sentito il sacro dovere di esprimere il proprio costante apprezzamento nei suoi confronti così come lui si sarebbe aspettato e così come avrebbe ritenuto assolutamente doveroso da parte altrui, che Trump stesso parrebbe piuttosto pronto a buttare alle ortiche decenni di consuetudini politiche collaudate e di relazioni internazionali di capitale importanza pur di continuare ad ottenere facili lusinghe da parte dei suoi sostenitori domestici ed internazionali e pur di danneggiare, al contrario, la vasta massa di critici che, oltretutto, hanno osato ostacolarlo in tutti i modi fin dall’inizio della sua presidenza, financo attraverso l’istituzione di una commissione di inchiesta sulle possibili interferenze russe nel corso delle elezioni presidenziali Usa. L’intera vicenda potrebbe sembrare quasi grottesca se non fosse per il fatto che gli Stati Uniti rappresentano il perno principale attorno al quale è stato edificato l’intero ordine mondiale del secondo dopoguerra e che il presidente Trump si stia prestando ad essere una sorta di (inconsapevole?) demolitore dell’ordine euro-atlantico, seminando discordia e producendo contrasti fra gli stessi alleati occidentali, il tutto a pieno beneficio di Russia, Cina ed alleati, i quali, dopo aver raccolto le macerie lasciate alle proprie spalle da Trump stesso e dai suoi “compagni di merende”, riplasmeranno nuove alleanze a loro uso esclusivo. Ripercorrere, pur per sommi capi, la vicenda politica dell’estrema destra americana degli ultimi anni è fondamentale al fine di analizzare il gravissimo stato di sofferenza geopolitica in cui versano sia gli Stati Uniti che l’intero mondo occidentale da questi dipendente. La crisi economica mondiale del 2007-2008, originatasi, non a caso, negli Usa, ha toccato l’intimo del cuore della società americana, la quale si trovava già da anni all’interno di una grave crisi sociale e culturale nonché identitaria. La stessa economia americana, fin dagli anni ’90 del secolo scorso, aveva iniziato a poggiare le sue fondamenta sulle sabbie mobili prodotte dalla globalizzazione e la tempesta finanziaria scatenata dai mutui subprime non ha fatto altro che mettere in luce tale stato di cose. Il neoeletto presidente Barack Obama, dopo aver cavalcato il malcontento della gente ed aver promesso una svolta radicale per il Paese, ha in realtà promosso una politica meramente volta alla gestione di quello che ormai sembrava essere l’ineluttabile declino degli Stati Uniti d’America. Tuttavia se da un lato la Casa Bianca ha ideologicamente preteso di mostrare con “eccessiva ostentazione” la debolezza degli Usa nel mondo, dall’altro Obama ha fortemente indisposto tutti coloro che si sentivano in qualche modo minacciati dalle politiche spiccatamente ideologiche di Obama stesso. La destra americana, alla disperata ricerca di un uomo forte al comando che la salvasse dal “mondo alla rovescia” proposto da Barack Obama, ha infine riconosciuto nella figura del presidente russo Putin una guida ideale a cui ispirarsi e da cui ripartire per ricostruire il Paese dopo otto anni di governo “castrista” del primo presidente americano di colore. Le politiche divisive e radicali di Obama unite agli effetti sociali della crisi economica hanno creato i presupposti affinché nella destra americana ci potessero essere le condizioni per un impensato avvicinamento ideale tra Mosca e Washington. Pur di evitare che ad Obama succedesse la “liberal” Hillary Clinton, le frange più estreme del partito repubblicano hanno avvallato non solo la candidatura di Donald Trump ma hanno addirittura accettato che l’aiuto di Mosca fosse determinante nell’elezione del presidente degli Stati Uniti. Appare evidente che una situazione di tal fatta risulti globalmente destabilizzante nonché fondamentalmente fatale per l’impalcatura sulla quale si regge l’intera costruzione geostrategica del mondo occidentale, soprattutto se consideriamo il fatto che lo stesso presidente americano e gli apparati burocratici tradizionali si trovano sovente su due linee di condotta palesemente opposte e complessivamente autodistruttive e paralizzanti. Si veda ad esempio il caso siriano, nel quale l’effimero attacco anglo-franco-americano contro gli ormai vuoti depositi di armi chimiche del regime di Assad è stato viziato da ogni genere di contraddittorietà: dalle remore di Mattis per un possibile conflitto con la Russia, alla necessità di Trump di creare una cortina fumogena mediatica finalizzata ad oscurare i numerosi scandali che lo affliggono. Appare evidente che gli unici beneficiari di una America ormai completamente alle deriva siano Russia e Cina, le quali, sfruttando i continui sbandamenti della Casa Bianca, stanno via via erodendo il terreno sotto i piedi del mondo occidentale.
L’insana politica dei dazi promossa dalla presidenza Trump nei confronti di alleati storici come l’Europa ed il Canada rappresenta il più grande regalo che la Casa Bianca potesse mai conferire a Mosca sia in termini politici che militari. Da un punto di vista della storia della politica internazionale, Donald Trump sta riuscendo laddove neppure l’Unione Sovietica aveva mai osato arrivare, ovvero sta iniziando a scolpire la pietra tombale sia della Nato che dei più vasti rapporti transatlantici oggi ancora in essere. Indubbiamente la crisi dell’Alleanza Atlantica possiede radici ben più antiche di quelle della presidenza Trump, tuttavia la contraddittoria politica dell’ “America First”, naturalmente benedetta dal Cremlino, sta fornendo il colpo di grazia ad un sistema di potere politico-militare che ha garantito settant’anni di pace in Europa ed ha allontanato lo spettro globale della guerra nucleare.
Nel caso della Corea del Nord, il regime di Pyongyang ha, a sua volta, ben compreso quali fossero la natura e le esigenze del nuovo inquilino della Casa Bianca e ha sfruttato la situazione a proprio vantaggio per ottenere un’insperata legittimazione internazionale da parte del Paese più potente ed influente del mondo. Da alcuni mesi la Corea del Sud, temendo che “crazy horse” Donald Trump, alla disperata ricerca di un qualche genere di successo sul piano internazionale da sbandierare ad uso domestico, sferrasse un attacco militare contro il Nord, ha cercato di forzare la mano della riappacificazione fra le due Coree rafforzando indirettamente l’ala più “aperturista” ed “anti-sistema” della amministrazione americana, alla fine ottenendo però in cambio il repentino consolidamento del regime del Nord della penisola, l’inquietante promessa formulata dallo stesso Donald Trump tesa ad un progressivo disimpegno Usa dalla regione (con grande soddisfazione della Cina) ed un fumoso impegno “bipartisan” per la denuclearizzazione dell’intera penisola coreana su cui francamente non si sa ancora assolutamente nulla (in tal senso Mike Pompeo non avrà gioco facile a convincere gli alleati asiatici degli Americani, come il Giappone e la stessa Corea del Sud, che Trump non intendesse affermare esattamente quello che ha promesso pubblicamente al dittatore nordcoreano). La politica della sanzioni alla Corea del Nord, per quanto possa aver avuto alcuni effetti positivi al fine di ammorbidire gli elementi più intransigenti del regime e di portarli al tavolo delle trattative, apparentemente non ha sortito gli effetti voluti perché se da un lato Russia e Cina hanno continuato a tenere in vita Pyongyang attraverso rifornimenti occorsi in mare in maniera semi-clandestina, dall’altro Mosca e Pechino hanno incoraggiato la Corea del Nord ad assecondare il peculiare modus operandi del presidente Trump, dato che a “The Donald”, in fin dei conti, sarebbe solamente bastato sbandierare ai media il presunto successo ottenuto a Singapore, non essendo in realtà questi minimamente interessato ad ottenere risultati concreti e politicamente impegnativi che siano in aperta contraddizione con l’imperativo categorico espresso dallo slogan elettorale “America First”. Alla fine dei giochi il regime di Pyongyang riuscirà probabilmente a conservare il proprio arsenale nucleare e missilistico con la benedizione sia di Pechino che del Cremlino.
Nel caso iraniano, il ritiro americano dall’accordo sul nucleare di Teheran rappresenta un’ulteriore degenerazione della politica americana, ormai, per l’appunto, caratterizzata più che altro solo da distruttivi messaggi mediatici o da poco altro. Le critiche della destra americana sull’accordo sul nucleare iraniano sono condivisibili nel loro impianto generale, tuttavia il ritiro unilaterale di Washington da tale intesa da un lato non produrrà alcun effetto sugli atteggiamenti iraniani in Medioriente dato che Trump, dopo aver estromesso la fazione più interventista del suo governo, ha confermato di volersi disimpegnare dallo scenario siriano una volta debellata completamente l’ISIS, dall’altro ha già generato un’ulteriore spaccatura tra Europa e Stati Uniti, il tutto a vantaggio sia della Russia che dell’Iran oltreché, da un punto di vista più globale, della Cina. Il ritiro americano dall’accordo sul nucleare iraniano, oltreché squalificare del tutto la credibilità diplomatica di Washington, non ha fatto altro che rafforzare la destra iraniana conservatrice, minando in questo modo l’autorevolezza politica faticosamente conquistata dell’ala riformista del Paese e mettendo in difficoltà coloro che, a cavallo tra il 2017 e il 2018, in buona fede (c’è chi sospetta che le manifestazioni di protesta contro il governo di Rouhani siano state in primo luogo opera degli ayatollah), sono scesi nelle strade delle maggiori città dell’Iran per esprimere il proprio dissenso nei confronti di un regime che drena le risorse nazionali per alimentare un insano avventurismo politico e militare nel Medioriente. Certamente la rinnovata crisi con l’Iran ha contribuito al rialzo del prezzo del petrolio, fatto forse non del tutto secondario per i gruppi di potere che sostengono il presidente Trump e che devono supportare opportunamente lo sviluppo dello shale oil americano attraverso un prezzo del barile adeguato.
Il teorema di Mosca formulato sul presidente Trump si è dimostrato corretto e sicuramente Trump rappresenta il miglior investimento politico che la Russia abbia mai fatto, perlomeno in tempi relativamente recenti. Certamente Trump non ha ancora il potere e la libertà di azione tali da riuscire a bloccare con un atto di imperio gli estremi tentativi degli apparati tradizionali americani di imporre sanzioni a Mosca, ciononostante, nel medio periodo, se le cose andranno come previsto dal Cremlino, l’intero edificio su cui si basa la politica sanzionatoria occidentale potrebbe andare in frantumi. Appare infatti evidente che mano a mano che Trump saprà prendere in mano in maniera sempre più efficacie e diretta le redini del potere, la sua influenza sugli apparati politici Usa e sui governi politicamente a lui affini si potrebbe accrescere con modalità forse oggi imprevedibili. In tal senso, come si è già visto nel corso dell’ultimo sorprendente G7, il trumpismo, smentendo senza remore le stesse politiche ufficiali della Casa Bianca, potrebbe trovare il modo di riportare la Russia fuori dall’angolo in cui l’Occidente stesso ha provato a porla senza nei fatti riuscirci. Inoltre questo calamitoso “trait d’union” in essere tra trumpismo, sovranismo e putinismo a poco a poco potrebbe sovvertire tutte le democrazie in crisi di identità del continente europeo, corrodendo passo dopo passo la già fragile opposizione alle politiche di Putin espressa da parte dell’Unione Europea. In questo contesto la prossima vittima di questa sorta di danza macabra tra gli Usa di Trump, la Russia di Putin e la Cina potrebbe essere proprio il “vecchio continente”. Lo scenario europeo appare in effetti assai sconfortante, già di per sé viziato da interessi economici nei confronti della Russia assolutamente dirompenti e divisivi. Il Regno Unito non riesce a trovare la quadra su una “Brexit” (una vera manna dal cielo per Mosca) ricolma di lati oscuri e si sta ritrovando sempre più isolato sia in Europa che nei confronti dei sempre più lontani partner americani, gli stessi su cui Londra sperava ingenuamente di appoggiarsi per supportare la Brexit sul piano internazionale nonostante la deriva “anti-establishment” di Trump stesso. Theresa May oltretutto è politicamente in difficoltà sia in Patria che all’estero ed i rapporti con Trump sono ai minimi storici dato che Trump non intende in nessun modo farsi dettare l’agenda politica dal numero dieci di Downing Street. A fatica il Regno Unito è riuscito a trovare adeguata solidarietà nel presidente degli Stati Uniti a seguito del caso Skripal e se altri partiti filorussi dovessero emergere vincitori dalle elezioni di importanti Paesi europei, Londra potrebbe trovare sempre più arduo supportare sui tavoli della diplomazia le proprie istanze internazionali contro Mosca. A riprova di quanto siano tese le relazioni tra Mosca e Londra basti ricordare che la Russia addirittura è recentemente arrivata ad accusare Londra di aver inscenato l’attacco chimico di Douma al fine di provocare l’intervento militare occidentale in Siria. La Francia di Macron ha tentato di svolgere un’azione di mediazione sia con Washington che con Mosca ma senza alcun successo sia sul caso siriano che su quello iraniano. Iniziative quali quelle del cosiddetto “Small Group”, tese a rivitalizzare una leadership americana sulla crisi siriana che però non trova supporto ai più alti vertici presidenziali, pur ben congegnate per buona parte degli intenti strategici proposti già contengono al loro interno i limiti di un’azione che non può essere sostenuta ai massimi livelli dell’organizzazione statale americana vista la politica trumpiana tesa ad un accomodamento con la Russia e a ribadire ad ogni occasione il mantra dell’ “America First”. In tale ottica non è chiaro in che modo Macron voglia farsi portavoce presso il presidente Putin di un organismo nato “morto” fin dalla nascita, avendo Trump “licenziato” Rex Tillerson, il quale sosteneva la necessità della permanenza dei militari americani in Siria in sinergia con i Curdi (causando tuttavia le ire dei Turchi) ai fini di garantire all’Occidente una credibile e realmente influente presenza strategica in terra damascena. Come se ciò non bastasse, continuare ad affermare da parte di Francia e Regno Unito che esista solo una soluzione politica alla crisi siriana appare più che altro come un sintomo di estrema debolezza visto che sia la Russia che l’Iran stanno imponendo la propria soluzione militare sul terreno la quale sta a sua volta plasmando in maniera inappellabile l’intero scenario geopolitico della regione. Parigi, principale sponsor della caduta del regime di Gheddafi, sta altresì guidando l’ennesima iniziativa di pacificazione in Libia, cercando di porre sotto la propria tutela il multiforme generale Haftar. L’attivismo francese non piace però all’Italia ed indubbiamente tutto ciò pesa e peserà nel rapporto fra i due Paesi, soprattutto ora che l’Italia si sta ponendo in contrapposizione ideologica con Macron anche a causa del problema degli immigrati clandestini che premono sul nostro Paese. Sia la Francia che il Regno Unito potrebbero a breve subire ulteriori contraccolpi geopolitici negativi relativi al fallimento totale della rivoluzione siriana, i cui ultimi brandelli superstiti potrebbero avere ormai le ore contate nel sud della Siria mentre probabilmente sopravviveranno in parte nel nord del Paese solo grazie alla spregiudicata politica di una Turchia ormai giocatrice libera alle prese sia con il deflagrante problema curdo lungo la propria frontiera meridionale che con il destabilizzante dilagare russo-iraniano nella regione. L’Europa oltretutto paga il prezzo delle sue contraddizioni nei confronti dell’Iran, avendo coltivato l’assurda e folle speranza di poter combattere “a basso prezzo” Teheran in Siria e contemporaneamente fare affari tranquillamente con essa in territorio iraniano, come se ciò non comportasse nessuna conseguenza sullo scenario internazionale. Appare certamente incredibile che l’Europa, a causa dei suoi numerosi interessi economici in Iran, sostenga, in piena contrapposizione politica con gli Usa, la conservazione dell’accordo sul nucleare di Teheran e che contemporaneamente l’Iran e la Russia, cerchino da un lato di fare fronte comune con l’Europa sulla questione dell’intesa sul nucleare iraniano mentre tentino allo stesso tempo dall’altro di scalzare l’Europa e l’Occidente nei rimanenti ambiti globali. Indubbiamente, però, i dazi americani all’Europa non stanno aiutando a pervenire ad una convergenza politica tra UE ed USA sulla questione iraniana. Nel mondo arabo le cose non vanno certamente meglio ed anzi la perdurante spaccatura tra Arabia Saudita e Qatar sta rafforzando il fronte iraniano ai danni sia delle sorti dello scenario geopolitico siriano che di quello libanese. I recenti dissapori in territorio yemenita tra le fazioni sostenute dall’Arabia Saudita e quelle supportate dagli Emirati Arabi Uniti rappresentano un ulteriore elemento di contrasto all’interno di una coalizione che con fatica sta cercando di contenere l’influenza iraniana in seno alla penisola arabica. Israele dal canto suo si rende ben conto che la situazione in Medioriente sia già sfuggita di mano agli Americani e se da un lato plaude al ritiro americano dall’accordo sul nucleare iraniano e al possibile ripristino delle sanzioni economiche dall’altro cerca di seminare zizzania tra Iraniani e Russi sperando che Mosca freni le pulsioni espansionistiche di Teheran. Il recente “viaggio della speranza” di Netanyahu a Mosca va certamente letto nella direzione di un sostegno israeliano al Cremlino in funzione anti-iraniana. La corresponsabilità israeliana nella decisione di Trump (deliberazione in primo luogo volta a soddisfare la destra americana filo-israeliana, la stessa che già ha preteso il ritiro americano dall’accordo sul nucleare iraniano) di spostare l’ambasciata americana a Gerusalemme non contribuirà al miglioramento della stabilità nell’area anche se la sostanziale accondiscendenza dei Paesi arabi sulla questione testimonia più che altro la maggiore preoccupazione dei Paesi del Golfo per l’inarrestabile dilagare iraniano rispetto a quella per le sorti dei Palestinesi, già di per sé abbastanza “collusi”, tramite Hamas, con i desiderata di Teheran. Certamente l’aver accresciuto i motivi di insoddisfazione dei Palestinesi e l’aver incrementato i punti di convergenza tra essi e l’Iran possono non essere considerati un’abile mossa da parte di Tel Aviv. Parimenti gli accordi che Israele, Russia e regime siriano starebbero realizzando “sottobanco” ai danni dei resti dell’opposizione siriana ubicata nel sud della Siria a ridosso del confine ed inerenti il controllo dello stesso a favore del regime stesso (ma ai danni dell’Iran) non fanno particolare onore agli statisti dello stato di Israele dato che se da un lato gli Israeliani forse stanno riponendo eccessiva fiducia rispetto alle proprie forze difensive e alle promesse di aiuto dell’alleato Trump, dall’altro Tel Aviv sta dimostrando una spregiudicatezza ed una doppiezza tale da lasciare alquanto perplessi per quanto tale situazione non susciti particolare stupore visto il clima da “si salvi chi può” in atto. I sempre più frequenti attacchi preventivi israeliani in territorio siriano contro postazioni di Iraniani ed alleati di Hezbollah potrebbero in realtà risultare complessivamente inefficaci sul piano strategico ed ulteriormente destabilizzanti per la regione, accrescendo la probabilità di un nuovo conflitto regionale che veda questa volta coinvolto Israele stesso. L’Iran, dal canto suo, non accenna a voler allentare la propria presa sulla Siria ed in Iraq non sembra aver particolarmente gradito l’esito delle ultime elezioni politiche.
Lo scenario che si prospetta è indubbiamente assai preoccupante. In Estremo Oriente Donald Trump ha appena sdoganato il regime nordcoreano, nei fatti contribuendo ad accrescere ulteriormente il determinante ruolo politico, diplomatico, economico e militare della Cina e della Russia sullo scacchiere internazionale. Il presidente degli Stati Uniti, pur inizialmente pavoneggiandosi dietro a toni bellicosi caratterizzati da elevata immaturità politica e personale, a fronte di un atteggiamento nordcoreano quasi di carattere adolescenziale, ha stabilito un surreale legame di reciproca comprensione filiale con Kim Jong-un (quasi da “paria” a “paria”), aprendo nei fatti la strada per lo sviluppo di relazioni similari (nel caso fosse Putin la controparte diplomatica, si presume che questi potrebbe impersonare, agli occhi del “piccolo” Donald, il ruolo del “Piccolo Padre” di zarista memoria) nelle quali nei fatti si potrebbe addivenire, a pieno vantaggio di Mosca e Pechino, ad una sostanziale legittimazione delle istanze geopolitiche russo-cinesi in seno alle maggiori aree di crisi internazionali, ovviamente ai danni sia dell’Occidente che dei suoi alleati. Naturalmente se tali considerazioni avranno effettivamente un seguito di carattere pratico, la stessa “diatriba” iraniana potrebbe infine concludersi, dopo alcune tonanti dichiarazioni di “rito” della Casa Bianca, con una sostanziale accettazione dello status quo imposto dall’Iran e sponsorizzato dalla Russia, ove però sarebbe Israele questa volta a subire i più pesanti contraccolpi causati da una mal riposta fiducia nel presidente Trump. Parimenti la crisi ucraina potrebbe conoscere il suo più triste epilogo con la fine del governo filo-occidentale di Kiev, fra l’altro finora incapace di far decollare una proposta politica concretamente alternativa rispetto a quella del precedente regime filo-russo. Il governo ucraino, sostenuto in maniera insufficiente dall’Occidente, è purtroppo dilaniato da destabilizzanti personalismi, da una endemica corruzione e dalla sostanziale incapacità di risolvere la crisi in corso con la Russia sia nel Donbass e nella Crimea. Tornando all’area del Pacifico, i dazi americani alla Cina appaiono più che altro come una sorta di mera foglia di fico di una più vasta “battaglia del grano” in salsa trumpiana contro i presunti nemici e sfruttatori globali dell’economia americana, quasi come se la sola egemonia mondiale del dollaro ottenuta “manu militari” non bastasse per formulare un’accusa di ampia e reiterata slealtà economica e commerciale degli Usa nei confronti di gran parte dei partner mondiali. I dazi promossi da Washington sono del tutto insufficienti per “spezzare le reni” a Pechino, anche perché l’economia “a stelle e a strisce” e quella “del dragone” sono da anni fortemente interdipendenti e questo a causa proprio delle errate politiche di delocalizzazione promosse dagli Usa stessi alla fine della guerra fredda. Oltretutto la politica dei dazi americani alla Cina collide con la richiesta di Washington di una collaborazione con Pechino per la denuclearizzazione della penisola coreana. Allo stesso modo i pattugliamenti per la tutela della libertà di navigazione promossi in larga misura dalla marina americana non stanno ottenendo nulla di concreto al fine di “sloggiare” la Cina dalle postazioni avanzate occupate in maniera illegittima nei mari dell’Estremo Oriente. In Medioriente Russia ed Iran stanno dettando l’agenda politico-militare mentre l’Europa, da settant’anni dipendente dalla macchina militare americana, è ormai politicamente bloccata a causa del drastico mutamento di rotta della stessa amministrazione statunitense e dell’insufficienza di adeguati mezzi logistici e militari che i Paesi europei ancora non hanno ritenuto di dover in qualche modo colmare nonostante i mutamenti geopolitici in corso. La scommessa di Cameron e Sarkozy, risalente al 2011 con l’avventura in Libia, finalizzata ad indurre gli Americani in crisi di leadership a condurre conflitti laddove le proprie politiche nazionali lo richiedessero o dove l’ordine internazionale lo esigesse, è stata tragicamente persa e lo si è visto chiaramente nel recente attacco condotto contro i già svuotati arsenali chimici di Assad, azione minimale che a stento è riuscita a concretizzarsi dato che gli Americani (il Pentagono) sono stati riluttanti fino all’ultimo nel condurre questo genere di operazione militare (lasciando fra l’altro tutto il tempo a Russi ed Iraniani di sgomberare completamente il campo) mentre May e Macron cercavano in tutti modi – ironia della sorte – di supportare Trump per non fare l’ennesima figuraccia come accaduto nel 2013.
L’Europa rimane pertanto sola in uno scenario di grave crisi della politica, dello stato di diritto e dell’ordine internazionale. L’Unione Europea possiede indubbiamente le sue colpe per l’attuale stato di cose. Le politiche del rigore “a tutti i costi” e della pervicace sordità alle esigenze dei Paesi più deboli dell’Unione hanno prodotto inenarrabili disastri come accaduto in Grecia dove tutt’ora non vi sono concrete speranze per un vero miglioramento delle condizioni di vita delle persone maggiormente in difficoltà. Intere classi dirigenti sono state spazzate via dalla crisi economica e dalle politiche di austerità di Bruxelles e nel vuoto creatosi sono penetrati movimenti di ispirazione populistica che traggono i propri riferimenti ideali non dai principi propri delle liberal-democrazie ma dai dettami dell’autoritarismo custoditi dalle gelide mura del Cremlino. In Polonia è insediato un governo di stampo autoritario che tuttavia teme l’aggressiva ascesa della Russia e mantiene pertanto una posizione filo-occidentale anche se fortemente trumpiana. In Ungheria l’autoritarismo di Orban, assai vicino a Mosca, è già ben noto. Sia la Repubblica Ceca che l’Austria sono guidati da governi che già da tempo salutano con fin troppo calore l’ormai eterno inquilino del Cremlino. La stessa Grecia viene considerata da alcuni come una sorta di centrale d’ascolto moscovita e certamente Mosca sta osservando con interesse la rinnovata rivalità fra Atene ed Ankara sul mare Egeo, in particolare ora che gli Americani appaiono abbastanza assenti anche da questo scenario. L’Italia ha scelto la strada “russa” nelle recenti elezioni e già se ne vedono alcuni effetti nei rapporti con la Francia nel merito della questione degli immigrati clandestini e, più in generale, sul tema della gestione della crisi libica. La consonanza con Trump del governo Conte, subito rimarcata nel corso dell’ultimo G7 in riferimento ai rapporti con la Russia, può trasformare l’Italia in un curioso laboratorio politico, ovvero il “Bel Paese” potrebbe tramutarsi nella spina nel fianco perfetta sia di Berlino che di Parigi anche se laddove in Europa Trump trova consensi è poi Putin a raccogliere un nuovo alleato mentre l’Occidente “guadagna” semplicemente un altro “cavallo di Troia” del Cremlino dentro casa propria. A fronte di tale situazione ciò che rimane di più genuino in Europa delle vecchie democrazie liberali risiede proprio in seno ai Paesi ubicati nella parte occidentale e settentrionale del “vecchio continente”, ovvero in quell’area vagamente identificabile con il mai completamente riuscito asse “carolingio-germanico” di nazionalità franco-tedesca il quale possiede quale unico e poderoso elemento persuasivo nientepopodimeno che la nostra moneta unica ovvero l’euro. Dato che nessun Paese aderente alla moneta unica per ora si è proposto seriamente di abbandonare l’euro, l’unione monetaria rimane al momento salva e con essa anche quel sufficiente peso politico ed economico che l’Europa con sede a Bruxelles può utilizzare per sopravvivere da un lato alle insidie della Russia e dall’altro alle politiche aggressive dell’America di Trump. Potremmo domandarci se oggi un’ Unione Europea forte convenga sia a Mosca che a Washington e probabilmente la risposta che saremmo costretti a darci appare negativa. D’altra parte il sostegno ideale che Donald Trump offrì alla Brexit fu orientato contro l’idea di Unione Europea stessa, non certamente per una sua personale simpatia nei confronti del Regno Unito come qualcuno oltremanica aveva voluto credere per via delle sue ascendenze scozzesi. A voler analizzare con estrema sincerità gli ultimi eventi della politica sia nazionale che estera, il vero pericolo che si sta insinuando in Europa e nel mondo è il lento riaffermarsi dell’autoritarismo e ciò ha potuto avere luogo in prima istanza a causa di classi politiche che da un lato non hanno saputo rispondere con solerzia e comprensione alle necessità reali delle popolazioni da queste amministrate e che dall’altro non sono state in grado né di incarnare né di promuovere la necessaria educazione politica che una società democratica necessita per poter perdurare con profitto lungo il percorso a volte accidentato della storia. L’attuale crisi del mondo occidentale trae origine primariamente da una crisi delle istituzioni democratiche e da una grave sofferenza sociale direttamente connessa alla crisi della classe media. In tal senso non possiamo certamente incolpare la Russia di tutti i mali relativi al nostro sistema elettorale, tuttavia Putin non ha fatto altro che osservarci con distaccata attenzione e colpirci laddove eravamo più fragili. Se pertanto vogliamo evitare che l’Europa naufraghi fra i flutti dell’autoritarismo putiniano e della volgarità trumpiana dovranno essere i governi europei ancora ispirati dai principi di libertà e tolleranza a trovare la strada per fermare questa deriva catastrofica sia per il “vecchio continente” che per il più generale ordine internazionale.
Se questa opera di recupero dei valori fondanti della civiltà occidentale non venisse effettuata con urgenza e con adeguata determinazione, temo che nessun Paese europeo, Germania inclusa, potrà considerarsi immune dalle ammalianti e dilaganti sirene del trumpismo e del putinismo ormai attestate con successo in mezza Europa e pronte ad insediarsi al governo di quei Paesi nei quali la politica tradizionale non risultasse in grado di resistere alla devastante tempesta geopolitica attualmente in corso.
su Frontiere
del 15 giugno 2018
Articolo originale