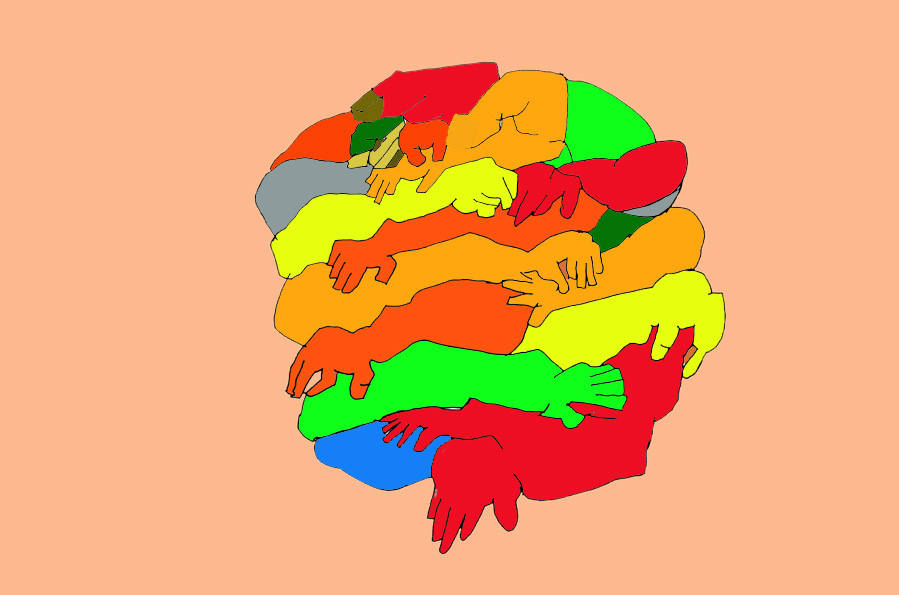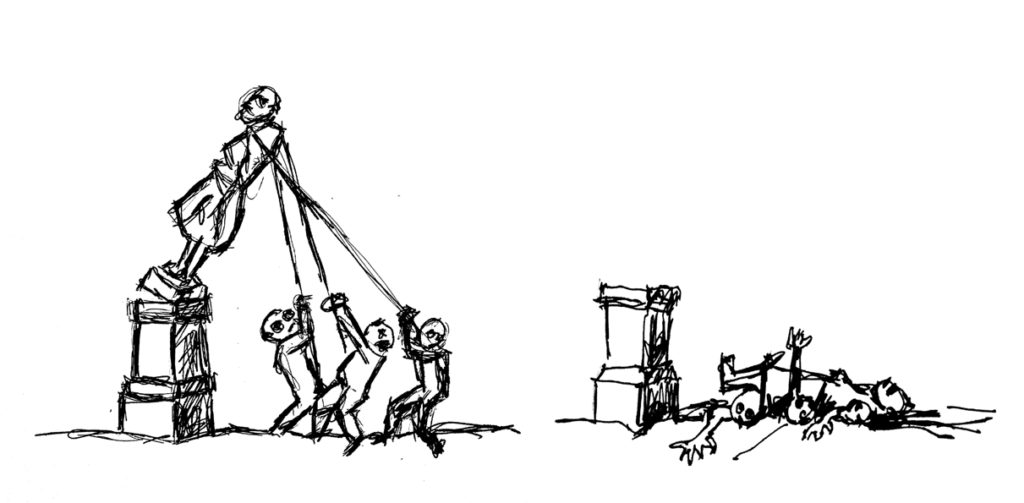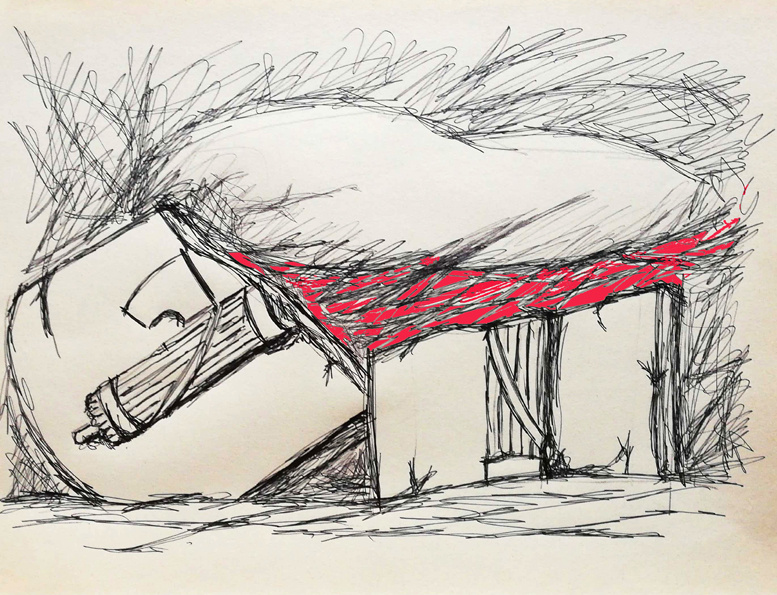
E’ recente la notizia del rifiuto della sindaca Virginia Raggi di autorizzare un romano Museo del Fascismo, iniziativa partita proprio da alcuni consiglieri del Movimento 5 Stelle ma subito bloccata dall’ANPI, la ben radicata associazione dei partigiani: Roma è una città antifascista, medaglia d’oro della Resistenza e l’unico museo possibile può essere quello dei crimini nazifascisti. Cioè un museo partigiano. Solidale la sindaca: “Roma è una città antifascista, nessun fraintendimento in merito”. Nelle pie intenzioni dei promotori (Maria Gemma Guerrini, Massimo Simonelli e Andrea Coia, mozione 264/2020) si parla di “un grande museo” da realizzarsi in un sito di archeologia industriale che “funga da polo attrattore per scolaresche, curiosi, appassionati ma anche turisti da tutto il mondo”, prendendo a modello “operazioni culturali di analisi critica del periodo del nazismo” (quali? Ndr.). Finalità culturale del museo sarebbe “la necessità di contrastare il negazionismo e l’ignoranza”. Il testo della mozione citerebbe inoltre i rigurgiti neofascisti che “anche recentemente hanno offeso Roma e i suoi cittadini”. Peccato che nella mozione non ci fosse alcuna condanna dei crimini perpetrati dal regime, né si prendeva in considerazione il rischio che l’iniziativa potesse finire per glorificare il regime anziché condannarne la politica. Come evitare che diventasse un pellegrinaggio di nostalgici? Cassandolo. E qui riemerge ancora una volta una questione aperta: l’Italia non ha mai fatto realmente i conti col suo passato e la storia moderna, oltre che non essere insegnata a scuola per la discutibile rigidità dei programmi, è in Italia ancora motivo di divisione.
Avendo lavorato per anni in un museo, mi permetto alcune osservazioni. Intanto Roma è piena di musei (sia pubblici che privati) bellissimi ma sconosciuti perché poco pubblicizzati, poco finanziati e poco valorizzati. In questo la dott.ssa Alberta Campitelli, già funzionaria della Sovraintendenza capitolina e ora referente italiana dell’ICOM (l’organizzazione internazionale dei musei) è stata chiara: prima di aprire altri musei valorizziamo quelli esistenti dando loro risorse adeguate. E aggiungo: concentriamone alcuni, soprattutto quando trattano argomenti simili. Non abbiamo un Museo centrale delle forze armate perché ogni arma e ogni reggimento vuole il suo, senza naturalmente trovar mai le risorse adeguate per gestirlo e tenerlo aperto in modo razionale. In questo senso l’iniziativa abortita conferma l’abitudine italiana di ragionare per categorie sindacali e minoranze organizzate: partigiani, ebrei, pensionati, istriani, gay, alpini, parà, rom, insegnanti precari. Ognuna di queste identità sociali alla fine vuole il suo giorno della memoria, il suo museo e i suoi contributi statali. Quanto a Roma, una soluzione non la propongo io ma rinfresco piuttosto la memoria ai miei distratti concittadini: del Fascismo storico si può parlare benissimo all’interno del Museo di Roma che, a suo tempo progettato e presentato ufficialmente sulla carta, è poi finito nel Nulla senza che nessuno ci abbia scritto un rigo o versato una lacrima. Allocato nell’ex Pantanella (poi Palazzo dei musei di Roma) a via dei Cerchi, dopo averne espulso gli uffici amministrativi presenti al suo interno (si è visto!), doveva essere strutturato in tre enormi piani: la Roma antica (recuperando quanto è conservato nel Museo della Civiltà Romana all’EUR), la Roma del Rinascimento e del Barocco, la Roma moderna. Progetto razionale, perché saldava la zona archeologica del Grande Campidoglio al Circo Massimo e poteva costituire un polo di attrazione culturale e turistico di eccellenza. Il progetto era curato dall’assessore Claudio Minelli e dal sovraintendente Eugenio La Rocca nel 2005-06, e fu ripreso in seguito dal suo successore Umberto Broccoli, nominato dalla giunta Alemanno. Cito la rassegna stampa dell’epoca:
A leggerla c’è da piangere: “Sono ventitremila metri quadri in totale di cui seimila disponibili in una prima fase. Rivoluzione non da poco ma non si tratta di chiacchiere né di «progetti di fantasia» bensì di lavori in corso: così, allineando tappe e date di un processo «in via di attuazione», il Campidoglio, nella persona dell’ assessore Claudio Minelli che si occupa del Patrimonio, replica all’ articolo a firma di Adriano La Regina apparso ieri su Repubblica: «Sono più di vent’ anni che se ne parla e non è mai stato fatto un solo passo avanti ma se così fosse sarebbe una bella notizia». Certo oggi non si può ancora pagare il biglietto ed entrare nel Museo di via dei Cerchi, ma domani è dietro l’ angolo” < … > «Sul tavolo ci sono ormai tutti i tasselli. I tempi saranno rapidi perché le difficoltà maggiori si incontrano proprio quando si tratta di liberare i locali, inoltre abbiamo anche fondi disponibili per la realizzazione del museo e ci stiamo occupando dell’ acquisizione dei materiali».
La documentazione completa è tuttora accessibile nel sito ufficiale di Roma Capitale:
Ma è verosimile che nessuno se la sia letta negli ultimi dieci anni, tantomeno gli incauti consiglieri che hanno proposto un nuovo museo. Ma è impressionante prendere atto che a Roma troppi progetti, trionfalmente presentati e anche validi, alla fine si confondono col Nulla.