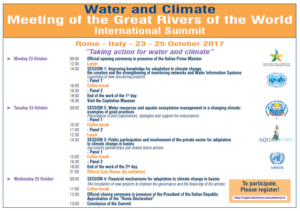Tornano. Sono costretti a tornare nel Paese da cui erano fuggiti per cercare un’esistenza futura. Sono migliaia di afghani che, come altri migranti e rifugiati, si vedono respinti dall’aria che tira in Europa, un’aria xenofoba fomentata o subìta dai tanti governi Ue. Che in troppe circostanze, e nelle più diverse latitudini, non hanno attuato un’adeguata politica dell’accoglienza e dell’inserimento delle emergenze migratorie, così da ritrovarsi decine di migliaia di vite in sospeso. E nelle condizioni più varie: dalle para-detenzioni di taluni centri di accoglienza, alla ghettizzazione e all’autoemarginazione in città e campagne di chi cerca di arrangiare un’agra realtà pur di non tornare negli inferni conosciuti. Di chi si fa fantasma sociale pur rientrando nella catena dell’uso e dello sfruttamento di mano d’opera. Un fenomeno discusso dalla gente per via, prima che dai politici nelle sedi istituzionali e nei salotti televisivi. Discusso spesso in assenza d’informazioni, lamentando le proprie contraddizioni crescenti, col sangue agli occhi per la contrapposizione dei diritti e lo scontro razziale e razzista che ne consegue. E l’Italia non è fra le piazze peggiori, visti i muri e le minacce sollevati in questi anni dal pensiero neonazista riagitato nell’Europa della tradizione e della conservazione. Indifferenti all’orgiastica competizione dell’assassinio di civili per accaparrarsi la leadership del terrore che è in atto da due anni fra talebani e Isis del Khorasan, i governi del nostro continente aumentano i rimpatri forzati di richiedenti asilo afghani.
Nel 2016 avevano respinto circa 10.000 individui, compresi molti minori, nell’anno che s’è chiuso la cifra è aumentata, nonostante siano cresciute le vittime nelle province dove gli afghani vengono rispediti. Ma a premier e ministri degli Interni dei Paesi dell’Unione, anche quelle anime politiche che si fanno belle di sani princìpi di cristiana ospitalità poco interessa il contorno esterno. Premono ragioni di Stato e i risultati elettorali di un’Occidente ormai assillato da paure e chiusure, una società che si asfissia in una futile tecnologia della pace, trasferendo i prodotti della propria tecnologia della morte nel mondo posto sotto tutela. Cui s’aggiunge la sciagurata potestà delle alleanze economiche e geostrategiche che disegnano i disastri presenti nei luoghi di crisi. Con l’ultimo governo locale, frutto delle fallimentari alchimie sperimentate nei sedici anni di occhi e mani sull’Afghanistan, l’Occidente ha siglato il patto “Joint way foward”. Come nei tanti progetti sparsi dall’imperialismo attorno alle sventure create, di condiviso in quella sigla non c’è nulla. Anzi, niente di più unilaterale si nasconde nella proposta rivolta al presidente Ghani. Se il Paese non accetterà di riprendere gli afghani che le nazioni rispediscono al mittente, Kabul, che già deve fare i conti coi serrati assalti jihadisti e talebani, vedrà tagliarsi i fondi con cui l’Occidente lo mantiene in un comatoso stato di sopravvivenza. L’Afghanistan risponde a una tipologia di rentier-state. Utilizzato dalla Nato, e principalmente dagli Usa, quale avamposto militare strategico per l’Asia. Le basi aeree di: Kabul, Bagram, Parvan, Charikar, Kandahar, Khost, Paktia, Maza-e Sharif, Jalalabad garantiscono al Pentagono osservazioni, controllo e incursioni tramite F-16 e droni.
L’altra rendita proviene dallo sfruttamento del sottosuolo dove, nell’ultimo quindicennio, sono state scoperte vene minerarie cui è interessata l’industria bellica e l’high-tech. In realtà molti rilievi erano stati fatti a inizi anni Ottanta, durante l’occupazione sovietica. I russi, da sempre attenti a fonti energiche e materie prime, avevano compiuto scandagli, sapendo che per conformazione geologica gli urti fra subcontinente indiano e piattaforma asiatica aveva stratificato vari metalli. Dal 2004 l’Us Geological Survey, grazie all’occupazione dell’Enduring Freedom, ha formalizzato le ispezioni attorno a giacimenti di rame, ferro, cobalto, alluminio, mercurio, litio e le famose ‘terre rare’, stimando in mille miliardi di dollari il patrimonio di quelle viscere. A sfruttare talune riserve, il rame ad esempio, copioso in un punto dove c’è un’antichissima area archeologica (Mes Aynak) è il China Metallurgical Group. Il governo Karzai ne cedette l’estrazione trentennale all’azienda di Pechino in cambio di tre miliardi di dollari. Come per altre concessioni avvenute in questi decenni (terreni per le basi aeree, terreni per la coltivazione dell’oppio) non se ne è avvantaggiato il Pil del Paese; i capitali sono finiti nelle tasche di uomini di governo, clan familiari, clan tribali, Signori della guerra. Perché chi vuol sfruttare le risorse, dall’esterno e dall’interno, consente solo questa via. In quest’Afghanistan vengono rispediti, a morire o patire, i ragazzi che cercano un domani nella vecchia Europa.
Enrico Campofreda
Pubblicato 30 gennaio 2018
Articolo originale
dal blog Incertomondo
nel settimanale Libreriamo



 Di un intervento italiano nel Sahel si parlava già dal maggio scorso con l’Operazione “Deserto Rosso”, ma la Difesa aveva smentito, ora è una realtà la presenza dei militari italiani nel Niger affianco delle truppe francesi, ma non per combattere, come ha tenuto a specificare il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, ma limitandosi ad «addestrare le forze nigerine e renderle in grado di contrastare efficacemente il traffico di migranti ed il terrorismo».
Di un intervento italiano nel Sahel si parlava già dal maggio scorso con l’Operazione “Deserto Rosso”, ma la Difesa aveva smentito, ora è una realtà la presenza dei militari italiani nel Niger affianco delle truppe francesi, ma non per combattere, come ha tenuto a specificare il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, ma limitandosi ad «addestrare le forze nigerine e renderle in grado di contrastare efficacemente il traffico di migranti ed il terrorismo».
 La nuova Cortina di Ferro all’interno dell’Unione europea vede ampliarsi il Gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) con lo spostamento a destra dell’Austria e che farà muro contro l’impennata d’orgoglio dell’Ue nell’attivazione delle procedure previste dall´Articolo 7 dei Trattati, quando si riscontrano delle violazioni gravi di uno Stato membro, la Polonia, dei valori fondamentali dell’Unione.
La nuova Cortina di Ferro all’interno dell’Unione europea vede ampliarsi il Gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria) con lo spostamento a destra dell’Austria e che farà muro contro l’impennata d’orgoglio dell’Ue nell’attivazione delle procedure previste dall´Articolo 7 dei Trattati, quando si riscontrano delle violazioni gravi di uno Stato membro, la Polonia, dei valori fondamentali dell’Unione.